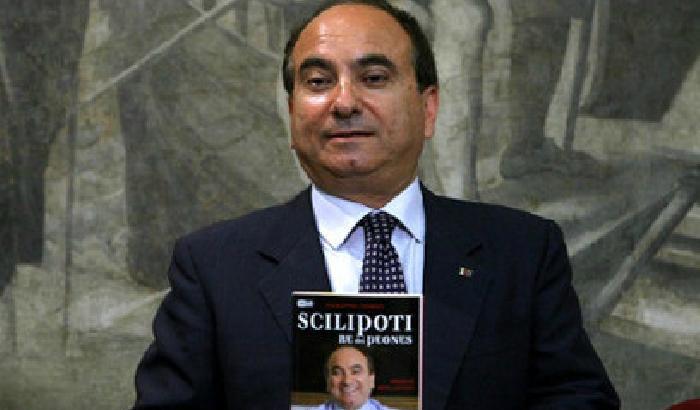Ogni mostra è mezzo di comunicazione, un dialogo che l’artista ingaggia con il pubblico. Si tratta di un percorso sempre carico di incognite, nel corso del quale quelli che sono i contenuti che l’artista mette nel suo lavoro sono continuamente negoziati, costantemente demoliti e ricostruiti dall’apporto interpretativo di chi la mostra non la fa, ma semplicemente la fruisce. E dove la risultante di questo processo biunivoco non sempre collima con le intenzioni iniziali dell’artista.
Ci siamo chiesti come questo dialogo condizioni la visione di chi, come nel caso di Persefone Zubcic, vive l’arte della fotografia sulla sua pelle, coinvolgendo nel suo fare tutta la dimensione intima dei rapporti familiari e delle amicizie. Oltre che se stessa. Glielo abbiamo chiesto alla soglia alla chiusura della sua mostra di Milano e del varo di una sua personale a Labin nel suggestivo centro culturale di Lamparna ricavato da una ex-fabbrica di carbone (http://www.labinary.org/lamparna/).
La tua prima personale ha destato approvazioni ed anche alcune critiche. Ti aspettavi che ci sarebbero state discussioni polemiche sul tuo lavoro?
Una mostra è necessariamente il momento di rapportarsi con il pubblico. E per me si tratta di un momento sempre positivo. La mostra di Milano è stata l’occasione per comprendere alcuni elementi che, in quanto parte di una ricerca che per me è istintiva e viscerale, erano ‘inintenzionali’ nel mio lavoro.
Quali sono gli elementi del tuo lavoro venuti alla luce nel corso della mostra?
Una cosa che non avevo considerato è l’assoluta anticonvenzionalità e irriducibilità del mio lavoro a qualunque corrente fotografica dell’arte presente. Che la mia fotografia, che pure trae le sue premesse da una curiosità documentaria per l’uomo nelle sue diverse dimensioni, che la critica ha riportato a Diane Arbus, è da me rivissuta alla luce della mia esperienza di fotografa di performance. Il risultato è nella sovrapposizione di una teatralità ricostruita, che viene dalla body art, all’attenzione quasi morbosa per il corpo e la sua ‘terrestrità’ bella e oscena, oscura e tormentata, illuminante e conturbata.
C’è stato qualche commento che hai trovato particolarmente calzante?
Per me il confronto con il pubblico non deve necessariamente essere vissuto in modo pacificante: vivo il rapporto con gli altri sempre sulla soglia del conflitto, e nel superare continuamente questo limite. In questo senso ho molto gradito le parole di Roberto Mutti, quando ha fatto riferimento al mio modo di concepire una mostra secondo un’ottica che lui ha definito ‘poco rassicurante’.
Si nota che anche laddove le modelle sono di indubitabile bellezza, in quella bellezza scorgi il difetto, l’imperfezione. A quale concetto di bellezza ti sei ispirata?
Il lavoro scaturisce da una riflessione sulla ricerca della perfezione fisica che è propria della nostra società, e che, secondo me, nasce da un’endemica paura del dolore e della morte, tipica del nostro modo di vivere sempre sull’orlo del presente. Dove questa paura è esorcizzata nella continua riproduzione di modelli di perfezione estetica e nella conseguente tendenza all’uniformità. A questa io rispondo con la ricerca dell’unicità in un corpo in cui, proprio per le sue imperfezioni e i difetti, vedo la radice della nostra caducità, e dunque dell’eternità. La bellezza per me risiede in un senso tragico dell’esistenza, che è la radice della nostra eternità.
Quindi ti ritieni un’artista cristiana, in qualche modo..
La cultura cristiana fa parte di me. Anche se io la vivo in modo completamente personale.
Torniamo al lavoro. La mise in scène che tu crei nella fotografia fonde il simbolismo sacro a tutta l’oscenità del corpo profano. In questa sovrapposizione, il corpo è un simbolo come un altro.
Il corpo, nella sua nudità contiene bellezza e bruttezza; è da qui che si origina la sua sacralità profonda. Sacro e profano sono per me le facce di una stessa medaglia. Non potevo non ispirarmi all’iconografia cristiana, che per me è stata elemento culturale fondamentale. Quello che ho fatto è stato aggiornare un concetto di nudità che è proprio di quell’arte antica, secondo la mia sensibilità, che è abituata ad immagini più forti di quelle di allora.
Con una sorta di sfrontata disinvoltura hai coinvolto in questa ricerca sul corpo nudo anche il rapporto con tua madre, in un ciclo di lavoro dal titolo Skandalon, in cui era coinvolto anche il suo compagno di vita. Come ha reagito il pubblico?
Mi ha stupito che quella parte della mostra è stata percepita come espressione di un concetto di intimità molto originale. In quelle foto il pubblico ha visto esaltato il rapporto d’amore e di venerazione che nutro per mia madre, artista con la quale collaboro sin da bambina. Ho scelto lei ed il suo volto per incarnare lo stereotipo visivo della maternità che, vissuta in Cristo, è amore, dolore e sacrificio.