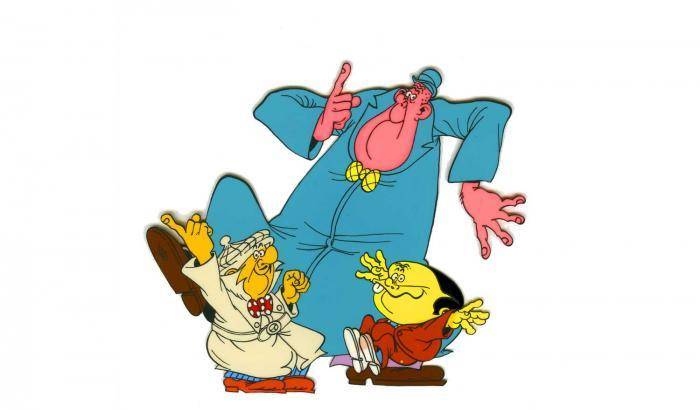Tom Wolfe l’ho incontrato, una sola volta. In Italia era appena stato pubblicato il suo ultimo romanzo, Le ragioni del sangue (si era sul finire del 2013), con la mia traduzione, e con questa “scusa” ero riuscito ad organizzare un colloquio. Mi ricevette al Carlyle Hotel, sulla Madison Avenue, a Manhattan. Attraversai l’androne che conserva qualche stridula eco degli antichi sfarzi, emozionato e un po’ in ansia per come mi avrebbe accolto quel personaggio, geniale esponente del new journalism, creatore della fortunatissima locuzione “radical chic” e romanziere di successo. Un concierge costretto in un’uniforme troppo risicata per il suo fisico corpulento mi condusse in una sala ammobiliata con arredi d’epoca, non poco stridenti con la chiassosa postmodernità che regnava fuori da quelle mura. Su un divano era accomodato un anziano signore, le gambe accavallate e un giornale artigliato tra le mani nodose. Il concierge gli si avvicinò compunto, gli sussurrò all’orecchio e si trasse in disparte. Sgombrò il campo solo quando l’anziano signore si levò lentamente in piedi, e con un sorriso che mi parve un filo ironico mi invitò ad avvicinarmi. Sì, era davvero lui, Tom Wolfe. Accuratamente abbigliato, proprio come appare nelle fotografie che lo raffigurano: indossava un abito crema d’altri tempi, con il panciotto, una camicia azzurra su cui spiccava una elegante cravatta chiara: così agghindato s’accordava perfettamente con l’atmosfera glamour da vecchia America che essudava da quella sala. Mi colpirono in particolare gli scarpini bianchi, d’una ricercatezza marcatamente demodé: un paio simili li ricordo in una foto di mio nonno, risalente agli anni Trenta del secolo passato. Mi strinse la mano, con gesto cordiale e a suo modo condiscendente, e mi invitò a sedermi accanto a lui. Forse per sciogliere il ghiaccio, esordì con una frase tipo: “Ach, a leggere questi giornali si rischia di morire dal ridere: alla mia età devo andarci piano”, accompagnandola con un sorriso sardonico che gli increspò ancor oltre il volto rugoso. Non ero ben certo di aver capito, e sorrisi imbarazzato. Lui mi piantò addosso i suoi lucidi occhietti acuti, e mi chiese: “Allora, giovanotto, cosa l’ha portata qui a New York ad incontrare un vecchio brontolone come me?” Farfugliai qualcosa ringraziandolo per avermi concesso quell’incontro, ma mi resi subito conto che quell’uomo si aspettava che andassi al sodo. Così gli spiegai che ero il suo traduttore italiano, e cominciammo a parlare del romanzo che mi aveva così duramente impegnato, per quella lingua mobile e creativa, personalissima, intessuta di neologismi, onomatopee, calchi del linguaggio della cultura di massa. Fu la scelta giusta. Rispose con cordiale disponibilità a tutte le domande che gli mitragliai, condendo le frasi con l’arguzia e la bruciante ironia che lo hanno reso celebre, la saggezza di chi ha attraversato da acuto osservatore lunghi decenni di storia. Parlammo dello stato delle lettere americane, della “disastrosa” (così la definì) situazione sociale e politica del suo Paese e mondiale. Mi disse che agli scrittori oggigiorno manca il coraggio di mettersi in gioco, di tuffarsi nelle nefandezze del vivere, li reputava privi della tensione morale che impegna a raccontare la realtà in tutta la sua crudezza. Quanto al giornalismo (ci tenne a precisare che si considerava un giornalista, più che uno scrittore), la situazione era ancora peggiore. Senza mezzi termini dichiarò che oggi viviamo tutti in una bolla di pseudoinformazione, monopolizzata dal grande capitale, costruita a colpi di blog, di social network e di frasi twittate, dove anche le verità più evidenti vengono negate. “Vede”, concluse, “il giornalismo non è in crisi: è defunto. In disfacimento, come l’America.” Beh, quel distinto signore non le mandava certo a dire. Una frase, poi, mi colpì come una freccia, dritta nel cuore: “E’ da quando ho cominciato a scrivere che mi convinco che quello che sto vivendo è il peggior momento storico di sempre, ma più vado avanti, più l’abisso si spalanca e pare non finire mai.” Le parole di un vecchio scettico, o quelle di un saggio che ha trascorso l’intera vita a raccontare con raro acume il tempo che viveva, smascherando con la sua penna mordace gli aspetti più retrivi, le ingiustizie e le ipocrisie della società americana? Ricordo anche la risposta che mi diede quando gli domandai se fosse infastidito dal fatto che la critica, soprattutto quella cosiddetta radical (che gliel’aveva giurata per quel suo mettere alla berlina gli ambienti che si autodefinivano “progressisti”), stroncava puntualmente ogni suo lavoro. “Macché. Casomai ne faccio un punto d’onore. Se un giornalista-scrittore viene troppo incensato, evidentemente non ha fatto bene il suo lavoro.”
Devo dire che mi stavo davvero emozionando, da quell’uomo si imparava sulla vita così come s’impara leggendo i suoi libri e i deliziosi reportage. Soprattutto mi commossi quando prese a raccontarmi dell’11 settembre, di quando dal suo appartamento nell’East Side era rimasto impietrito nel vedere un fungo di polvere levarsi sopra il profilo di Manhattan, dopo il collasso delle Torri gemelle, e la paura che l’aveva colto, fin quando aveva visto un fiume di persone scendere giù da Madison Avenue e dalla Quinta Avenue, un flusso umano silenzioso e ordinato, e come quella scena quasi assurda gli avesse restituito il coraggio. Ma d’un tratto si avvicinò un signore attempato, vestito anch’egli di tutto punto, e l’incanto s’infranse. L’incontro era finito: raccolsi il libro che mi ero portato dietro, impreziosito dalla sua cortese dedica vergata con una raffinata penna stilografica tratta dal taschino, ringraziai sentitamente e mi allontanai per quei saloni, così tristi nel loro smaccato stile retrò.
Il vuoto che lascia ogni grande uomo che ha marcato un segno nel nostro immaginario, nel caso di Wolfe narrando il proprio tempo con arguzia e profondità, la tristezza di una simile perdita, li combatto con la fatua considerazione che in fondo sono stato il traduttore italiano che ha avuto la ventura di rendere nella nostra lingua il suo ultimo romanzo, una riflessione acutissima quanto esilarante sulla nostra vacua postmodernità resa attraverso il microcosmo allucinato di una metropoli, la multietnica Miami. E mi accompagna il ricordo di quella voce senile, affabile e garbata, lo sguardo intelligente di quegli occhietti mobili che si esprimevano in una lingua tutta loro, comprensibilissima, fatta di saggezza ed ironia, che prima di congedarmi si appuntarono sui miei, brillanti di cordialità e di calore umano. Le sia lieve la terra, caro Tom.