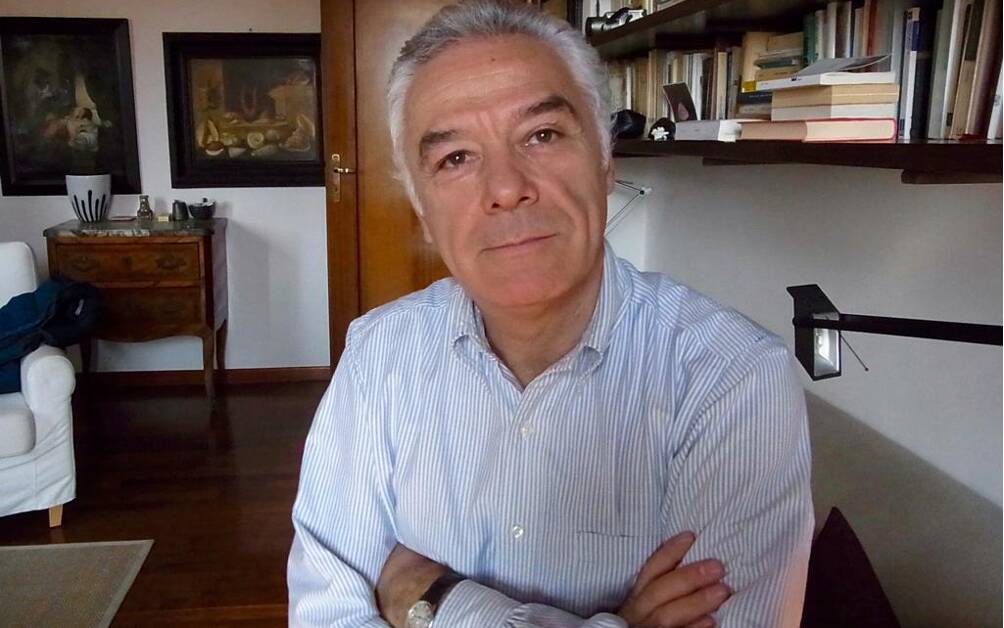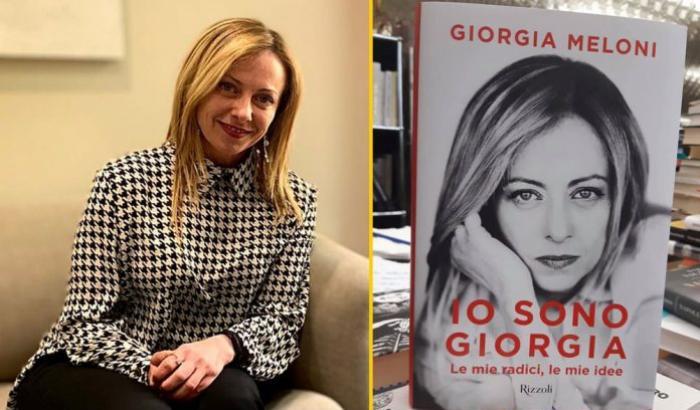di Rock Reynolds
In Italia per promuovere il suo nuovo libro, presentato tra gli altri in un’anteprima del festival “Dal Mississippi al Po” e nell’ambito del “Salerno Letteratura, la scrittrice israeliana Ayelet Tsabari si è concessa con profondità alle nostre domande, concentrandosi inevitabilmente anche sulla situazione attuale del suo paese.
Yemenita d’origine e con doppio passaporto (israeliano e canadese), la Tsabari aveva già mostrato di che pasta letteraria fosse fatta con la sua prima prova, Il posto migliore del mondo, una raccolta di racconti che ha fatto da anteprima a L’arte di partire (Nuova Editrice Berti, traduzione di Cecilia Mutti, pagg 378, euro 18), uno straordinario memoir in grado di avvincere come un romanzo, commuovere come un diario intimo e intrigare come un reportage geopolitico. Al suo interno troverete curiosità sul variegato universo culturale ebraico, pagine di grande lirismo e pure momenti in cui l’ironia ha il sopravvento.
Sappiamo bene che nel cuore mediterraneo del Medio Oriente c’è uno spicchio di mondo, lontano e vicino allo stesso tempo, grande grosso modo come un decimo dell’Italia: Israele, culla riconosciuta della cultura mondiale, teatro di guerre di religione e per il controllo del territorio. Ayelet Tsabari da quello spicchio di terra ha sentito di dover allontanarsi e a quello stesso fazzoletto di terra insanguinata ha capito di dover far ritorno. Anche se, come sta scritto ne L’arte di partire, “La mia casa è la pagina bianca. Il solo posto dove voglio sempre ritornare”.
Che impatto reale ha la religione su uno degli stati religiosi per antonomasia?
Credo che la situazione sia meno monolitica di quanto si pensi. Israele è certamente lo Stato-Nazione degli ebrei ed è stato fondato come tale, ma ci vive tanta gente che, come la sottoscritta, è tutto sommato distante dalla religione. E ci abitano tante persone che non sono di religione ebrea. Ciò detto, è impossibile ignorare la natura confessionale di Israele, anche perché talvolta ne risentono aspetti banali della quotidianità. Per esempio, nel giorno dello Shabbat, il servizio degli autobus pubblici si interrompe. Per una come me che è sempre in movimento è una vera scocciatura. Per altri, invece, è uno degli aspetti piacevoli della giornata di festa. Mi domando se succeda qualcosa di simile anche in Italia, con la religione cattolica.
L’immagine letteraria dell’ebreo errante le sta stretta?
È buffo, ma ho chiamato per un certo periodo il mio conto corrente “Conto Ebrea Errante”. Per un lungo periodo ho cercato la mia identità lontano da Israele, ma poi ho finito per sentirne la nostalgia. Perché è solo quando ti fai delle domande che il quadro prende forma. E io le domande me le sono fatte nel momento in cui ho iniziato a scrivere seriamente, proprio mentre viaggiavo.
Com’è stato nascere e crescere ebrea yemenita in un paese dominato dagli ebrei aschenaziti, ovvero quelli di lingua e cultura yiddish, provenienti dall’Europa centrorientale?
La cosa che spesso sfugge è che in Israele gli ebrei arabi sono più del 50% della popolazione. La classe dominante, però, è aschenazita e aschenazita è da sempre la cultura dominante del paese. Negli anni dell’infanzia questa dicotomia l’ho avvertita poco, anche perché la mia famiglia abitava in un quartiere misto. Ma alcune piccole, sottili discriminazioni le percepivo comunque: noi ebrei yemeniti non avevamo un ruolo importante nei libri, in televisione, sulla stampa e, quando venivamo rappresentati, quella che ne veniva fuori era immancabilmente un’immagine stereotipata, caricaturale. Insomma, per liberarmi di quel peso mi ci è voluto parecchio, anche perché da bambina avrei voluto essere diversa, essere bionda, avere l’aspetto che non avevo. E, a scuola, le lezioni di storia non parlavano mai di noi. È stato quando ho iniziato a scriverne e, per riuscirci, a fare domande specifiche ai miei familiari su certi “non-detti” che alcuni segreti ben custoditi della mia famiglia sono emersi, aiutandomi a capire meglio le mie radici.
Esiste davvero, come scrive nel suo libro, una sorta di magia nelle parole?
Se non ci credessi, non sarei una scrittrice. Le parole fanno la differenza. Libri e parole mettono le persone nelle condizioni di provare empatia, le espongono a universi nuovi, rendono il mondo più piccolo, fanno sentire l’altro meno “altro”. Attraverso le parole, dopo essermi sentita per anni sottorappresentata come ebrea yemenita, finalmente oggi avverto quella magia nella mia vita.
Israele: uno stato in guerra. La sua descrizione del servizio militare non è esattamente lusinghiera…
Il problema del servizio militare, non solo in Israele, è la sua obbligatorietà. Non mi ci sono mai trovata bene. Avevo solo 18 anni e ho fatto di tutto per scontrarmi con un sistema che trovavo sciocco e inutile. Non avevo la minima lungimiranza e proprio non mi andava giù l’idea di dover obbedire a ordini, spesso impartiti da superiori decisamente inferiori a me sul piano intellettuale. La verità è che sentirmi più intelligente mi ha spinta a comportarmi da scema, a fare cose che mi si sarebbero ritorte contro. Ho parecchi amici che se la sono spassata e penso di averne scritto in tono tutto sommato comico, ma per me non c’è stato nulla da ridere. È stata un’esperienza deprimente, una sorta di continuazione dell’esperienza negativa della scuola, periodo in cui non mi sentivo minimamente inserita. Ci sono molti ragazzi e molte ragazze che, subito dopo aver assolto agli obblighi di leva, partono per lunghi viaggi verso luoghi esotici come spiagge dell’India o della Tailandia per avvertire di nuovo un senso profondo di libertà, di disimpegno. C’è pure chi lo fa perché in quei due-tre anni ha incontri ravvicinati con la morte e ha bisogno di nuova linfa vitale. Per me, semplicemente, il militare è stato una noia assoluta.
Da ebrea yemenita che effetto le fa la condizione difficile dei vicini di casa palestinesi?
Ho grande solidarietà per la loro condizione, per la questione palestinese. Detesto ciò che vedo. Sento un legame profondo con quella gente. Negli anni di peregrinazioni in giro per il mondo, la nostalgia di casa mi ha spesso portata a cercare qualcosa che ne alimentasse il ricordo. A Vancouver ho lavorato per un ristorante mediorientale, giusto per cogliere certi sapori, certe sensazioni, perché mi sento mediorientale. Ho una connessione stretta con la terra dei miei avi, cioè lo Yemen e, al pari dei palestinesi, mi identifico con la mia terra d’origine. La questione è semplice: nessuno dei due popoli se ne andrà dalla sua terra. Dunque, dobbiamo vivere insieme. In un modo o nell’altro. Semplice, giusto?
Lei dice che l’assassinio del primo ministro Yitzhak Rabin è stato per voi israeliani uno spartiacque simile a quello del presidente John Kennedy per gli americani. Ha ricordi vividi del momento in cui lo venne a sapere?
Molto vividi. Ero in macchina con due amici e stavamo andando allo zoo di San Diego quando la radio interruppe il brano musicale in onda per dare la notizia. Spegnemmo la radio e accostammo. Eravamo letteralmente sconvolti. Con il governo Rabin, il nostro paese aveva vissuto per la prima volta la speranza che la guerra potesse cessare e che il nostro popolo e quello palestinese potessero vivere in pace. Ovviamente, gli accordi di Oslo non erano esenti da problematicità, ma la speranza c’era. Faccio parte di una chat su Facebook che include israeliani e israeliani-palestinesi e questi ultimi mi dicono di sentirsi oggi meno “israeliani” di prima che Rabin venisse assassinato. D’altro canto, nel paese c’è una sorta di assuefazione a quella che viene da noi chiamata comunemente “la situazione“ e non “la guerra”. Per questo ne scrivo, per esorcizzare quella che non può essere solo una situazione.