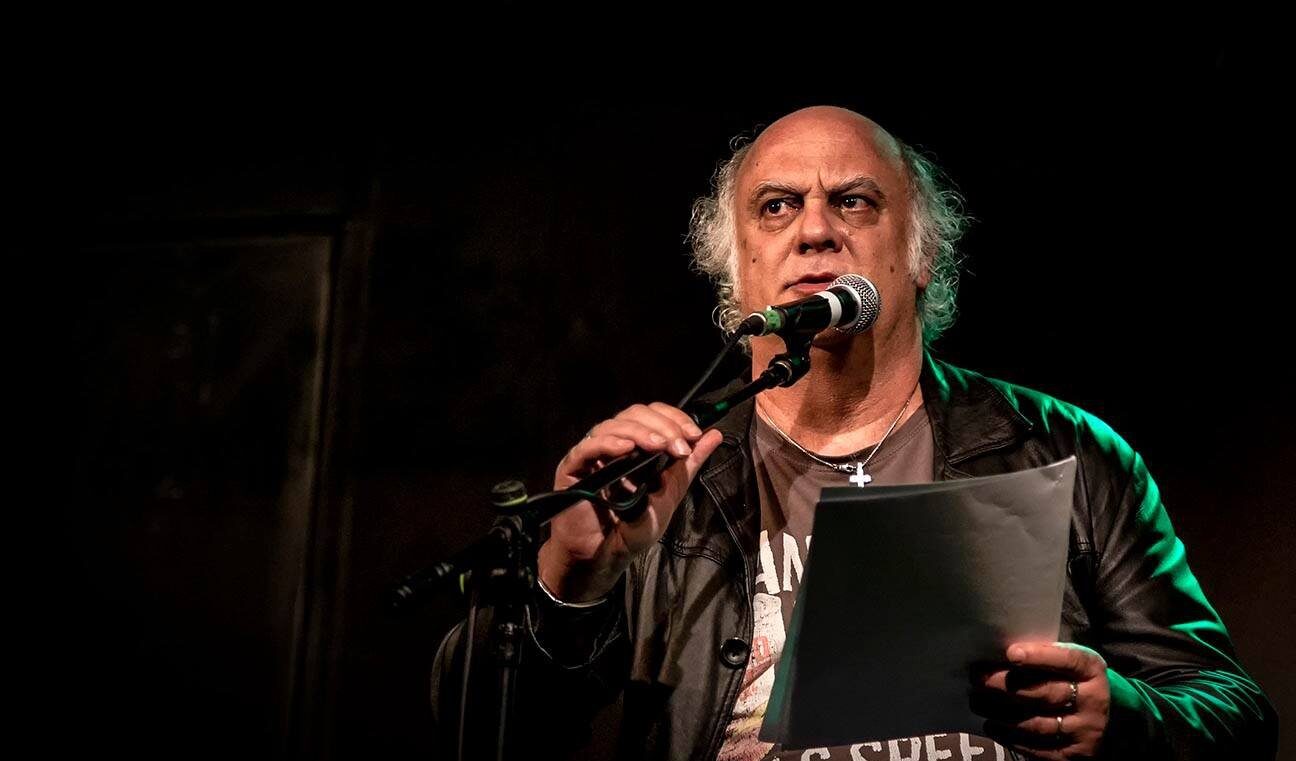di Rock Reynolds
Belli e dannati. Un accostamento talmente banale da risultare persino fastidioso. Un po’ come genio e sregolatezza. Abusare delle frasi fatte per descrivere le tendenze contrapposte di questo o quell’artista è un vezzo, anzi un vizio, inveterato che, se da sempre svilisce la critica dell’arte in generale, appare con frequenza diabolica in articoli di giornale, servizi televisivi e radiofonici e, perché no, saggi e monografie sulla musica moderna. È pur vero che, da quando il business ha messo gli occhi sul mondo dello spettacolo e, in particolare, sulla musica – si potrebbe dire che così sia sempre stato, almeno fin dalle rappresentazioni teatrali nell’antica Grecia – avvenenza e forza espressiva sono sempre andate a braccettp. Da quando Elvis, nel 1954, sfondò le porte dell’etere con il suo singolo di debutto, “That’s All Right” (un brano di un oscuro cantante blues, Arthur “Big Boy” Crudup, del 1949), non è più stato possibile spaccare quel binomio: di fatto, da allora, non è apparso un solo volto, maschile o femminile, nel mondo della musica che non esercitasse forte attrazione ancor prima di suonare una nota. Nella musica, non solo nel pop: oggi, persino la musica classica ha scelto un approccio glamour.
Grazie al cielo, non troverete analisi eminentemente estetiche né abbondanza di pettegolezzi (malgrado la materia trattata si presti a quella deriva) nel bel libro Rock’n’Roll Suicide. Il lato oscuro del rock (Caissa Italia, pagg 191, euro 19,50) di Paolo Vites. Con garbo e con una conoscenza del tema che lascia intendere una vicinanza più che di facciata a chi, nella vita, ha patito il male oscuro e lotta quotidianamente con una sofferenza che la società ancor oggi spietatamente fatica ad accettare, Vites si apre ai lettori. Il suo libro inizia come una sorta di flusso di coscienza, uno sfogo per la sofferenza che la morte autoinflitta di un amico gli ha creato. È un grido di dolore e anche un tentativo (in larga parte riuscito) di andare alla radice del problema e di contestualizzarlo dal mondo patinato e spesso, non del tutto a ragione, giudicato privilegiato della musica. L’amico in questione è Neal Casal, un bravo chitarrista e cantautore, un talento poliedrico a cui la vita pareva aver dato quasi tutto e a cui, invece, alcuni anni fa decise di porre fine violentemente.
Come succede quasi sempre, decisioni così drammatiche non vengono prese nello spazio di un mattino in cui ci si è svegliati con la luna di traverso o nel corso di una nottata in cui la solitudine ha morso i garretti di un’anima in pena. Ci possono essere eventi che precipitano o accelerano una presa di coscienza. E, talvolta, non basta nemmeno il paracadute di un contorno familiare e/o amicale forte. Mi viene in mente il caso drammatico di Chris Cornell, morto impiccato in una camera d’albergo nel corso di una reunion dei Soudgarden. Pare che avesse una splendida famiglia che lui amava, entusiasticamente corrisposto. Paolo Vites fa piazza pulita dei luoghi comuni, liquidando senza troppi giri di parole le sciocchezze che sono di casa in buona parte dei testi sul rock e i suoi eccessi. Non posso fare a meno di pensare a un classico della letteratura pop, No one here gets out alive (“Nessuno uscirà vivo di qui”), libro epocale e per molti anni unico testo di riferimento sui Doors, ribattezzato dai veri amici di Jim Morrison, “Nothing here but lots of lies” (Nient’altro che balle).
Di menzogne e ricami gossippari per vendere due, magari tre copie in più in questo ambiente se ne leggono tanti. Paolo Vites, dopo aver introdotto il tema depressione con una serie di punti scientifici, spiega le ragioni della dedica all’amico Neal e poi traccia un quadro inquietante di un mondo, quello del pop, che non fa sconti a nessuno. La depressione è il male del millennio, anche se in realtà l’accelerazione dei ritmi vitali, l’indifferenza diffusa e la disumanizzazione dell’artista hanno amplificato la portata di ciò che è sempre esistito. “So you want to be a rock’n’roll star”, una celebre canzone della band californiana degli anni Sessanta, i Byrds, diceva le cose in modo chiaro: “È ora di andare in città/L’agente non ti deluderà/Venderai l’anima alla compagnia/Che non aspetta altro che vendere paccottiglia”. Una persona che per anni aveva bazzicato nel mondo discografico me ne diede conferma: “Conosciamo le debolezze dei nostri artisti e le alimentiamo con piacere”.
La fragilità è il traballante substrato su cui l’alienazione derivante dagli adrenalinici alti e bassi della fama costruiscono l’invalicabile muro della sofferenza. Luigi Tenco non era certo un titano e di sicuro non lo era Kurt Cobain, lui, sì, una sorta di dio vichingo della bellezza e della creatività ribelle. Per lo meno finché non finì nel tritacarne dello star system, lui che aveva avuto un’infanzia segnata dalla separazione dei genitori e che, come molti colleghi in situazioni analoghe, aveva medicato i propri vuoti con farmaci in dosaggi fuori controllo medico.
Non crede più nessuno alla favoletta della star viziata e viziosa. Alla base di gesti estremi o incidenti involontari senza ritorno non può esserci soltanto una folle tendenza agli abusi e all’autodistruzione. Le fondamenta della malattia sono antiche e, talvolta, attendono la scintilla giusta – sarebbe forse il caso di dire sbagliata – per accendersi e poi deflagrare. In Rock’n’Roll Suicide non manca un capitolo dedicato a Nick Drake, una delle figure più anomale nel panorama della musica pop, un talento assoluto, una gemma pura, al punto da non riuscire mai a mediare tra le sue insicurezze patologiche e le richieste del music biz. Nessuno può realmente dire che Nick non si sia suicidato oppure che la dose eccessiva di farmaci assunti sia stata un errore. Non cambia la sostanza dei fatti. Così come non fa nessuna differenza che due artisti planetari del calibro di Prince e Tom Petty, due autentiche superstar, siano morti in situazioni non molto diverse, entrambi vittime di un abuso di antidolorifici e tranquillanti autoprescritti per i dolori ormai insopportabili e per l’incapacità di rinunciare ai ritmi dell’esistenza da star, uno stile di vita che esige un forte tributo personale ai suoi eroi. C’è chi, come Richard Manuel, pianista e voce d’angelo di The Band, forse il gruppo nordamericano più influente a cavallo fra gli anni Sessanta e Settanta, dopo aver respirato l’aria rarefatta dell’olimpo del rock con un mega tour a supporto del Bob Dylan novello rocker, si ritrovò a esibirsi in un circuito di localini di provincia di fronte a un pubblico bolso e disattento e non resse alla pressione: una corda, un cappio, una lauta bevuta e addio mondo, in una misera camera di motel. La storia di Michael Hutchense, iconico cantante del gruppo australiano Incx, è una delle più tristi: impiccato a sua volta in una camera d’albergo, solo e disperato. Il suo suicidio fece da fosco preludio alla morte della sua compagna (ex-moglie di Bob Geldof) e, in seguito, a quella della figlia secondogenita avuta da Geldof, entrambe per overdose di eroina. Che dire poi di Whitney Houston e Dolores O’Riordan (l’eterea cantante di Cranberries), morte giovani e accomunate dal fatto di essere state custodi di terribili violenze subite nell’adolescenza?
Il mal di vivere non è appannaggio di questa o quella categoria professionale, di questo o di quel ceto sociale. Arte e disperazione sono accostabili tanto le sono vita e disperazione. Vites, però, riporta le parole illuminanti di John Bollinger, ottimo chitarrista nonché amico di Neal Casal: “Poeti, scrittori, musicisti nel corso dei secoli sono sempre state persone sensibili che cercavano uno sfogo per questa bellissima tristezza”. Non può essere un caso se uno studio ufficiale ha sancito che “il 50 per cento dei musicisti ha riportato sintomo di depressione. Gli studi ci dicono che i problemi di salute mentale sono più diffusi tra le persone creative”. Se da una parte ci sono le superstar, con la pressione che il sistema impone su di loro, dall’altra c’è pure uno stuolo di “manovali” della musica, di musicisti oscuri la cui preoccupazione primaria è sbarcare il lunario in uno degli ambienti professionali più aleatori e ingrati che vi siano. È un patto col diavolo. Solitamente, si sa chi ha il coltello dalla parte del manico.