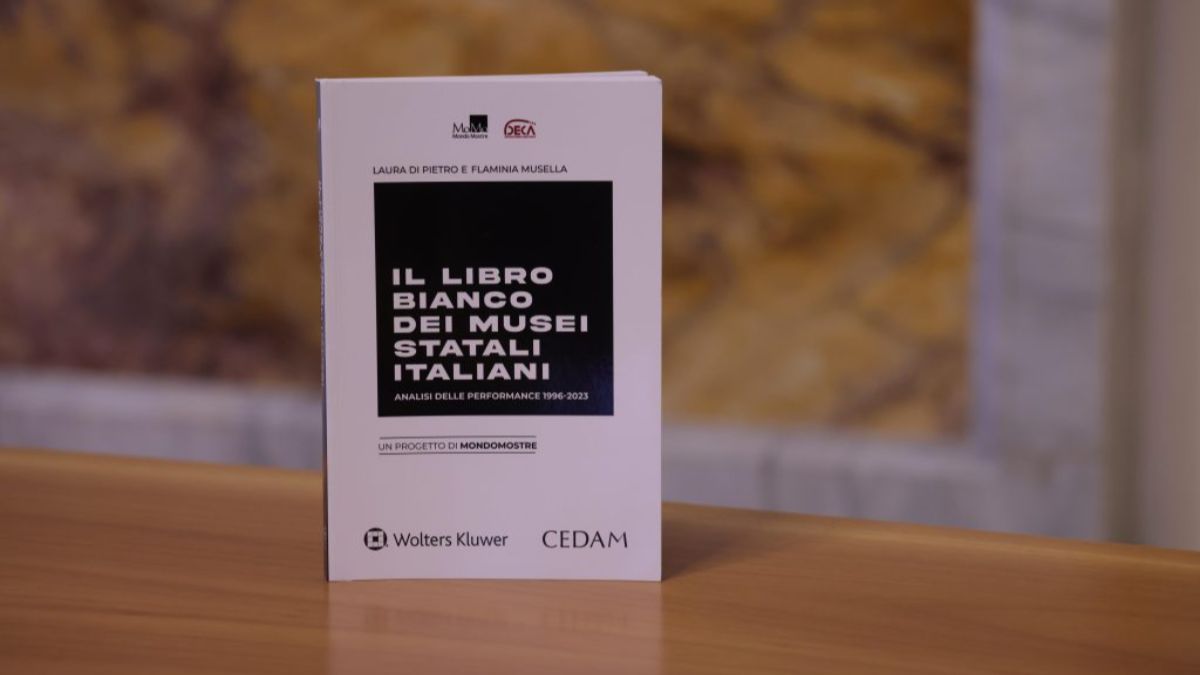di Antonio Salvati
Spesso le analisi più lucide sulla realtà sono poco rassicuranti. Come l’ultimo volume di Paolo Pagliaro, Cinque domande sull’Italia. I dilemmi di un Paese inquieto (Il Mulino 2022). Un libro decisamente interessante e dolente, quello di Pagliaro, giornalista noto per il suo Punto nell’ambito della trasmissione di Lilli Gruber Otto e Mezzo. Con l’ausilio di dati e numeri, l’autore ci consente di immergerci nella realtà di un Paese, il nostro, del quale spesso nutriamo un ritratto assai distorto. Il suo volume è una vera e propria miniera di dati decisamente indispensabili per meglio comprendere la realtà del nostro paese. In tal senso, è assai arduo dare conto compiutamente alle cinque domande sull’Italia, efficacemente sviscerate da Pagliaro.
Noi italiani siamo ricchi o siamo poveri? È la prima domanda del libro, assai ricorrente in quest’ultimi anni, cosiddetti del declino e che ritorna prepotentemente oggi nel tempo della cosiddetta «resilienza». Non è possibile evadere il quesito con pochi dati ad un quesito che – spiega Pagliaro – «ha a che fare con l’autostima, con la disponibilità a fare sacrifici, con i progetti di vita e con la fiducia nella politica e nella democrazia». Inoltre, non siamo un paese particolarmente omogeneo, bensì un arcipelago di classi e di tribù, di ceti e di generazioni, e soprattutto di individui. L’Istat, nei suoi dati più recenti, c’informa che abbiamo 5,6 milioni di poveri, il 9,4% della popolazione. Una persona è povera se ha un reddito inferiore a 640 euro al mese. In realtà, si può essere poveri anche guadagnando il doppio. Una famiglia con un figlio a carico è considerata relativamente povera se il suo reddito netto mensile non raggiunge i 1.400 euro. Ce ne sono 2,6 milioni. Pertanto, esistono tanti modi di essere poveri. Povertà mai conosciute prima, come quelle degli insegnanti, dei rider e degli altri addetti all’economia dei lavoretti, o dei piccoli esercenti rovinati da Amazon prima e dalla pandemia poi. C’è la povertà generata, più che dai bassi salari, «da quella patologica diffusione del part-time involontario che finisce con il dimezzare salari in teoria accettabili. È la situazione in cui si trovano tre lavoratori dipendenti su dieci, in grande maggioranza donne. C’è la miseria degli esclusi dal mercato del lavoro, in particolare giovani e di nuovo donne, e quella dei braccianti o dei manovali stranieri. Infine c’è la povertà posticcia degli evasori fiscali, delle facce di bronzo che, addomesticando l’Isee, sono esentati dal ticket per la mensa del bambino che ogni mattina accompagnano a scuola con il Suv. Fanno parte anche loro di quel 43,6% di contribuenti che paga solo il 2,3% del totale Irpef. Confina con queste povertà e aspira al benessere l’universo sempre più inafferrabile che sociologi ed economisti chiamano ceto medio, ciascuno intendendo cose diverse: i primi attenti al tipo di occupazione, i secondi al reddito e alla ricchezza».
Eppure la Banca d’Italia fa sapere che la ricchezza netta delle famiglie italiane ha raggiunto i 10.010 (diecimila e dieci) miliardi di euro, 8,7 volte il reddito disponibile. Un tesoro formato per la metà da immobili e per il resto da attività finanziarie. Nei 21 mesi intercorsi tra marzo 2020 e novembre 2021 il numero dei miliardari italiani della cosiddetta «Lista Forbes» è aumentato di 13 unità e il valore aggregato dei patrimoni dei super-ricchi è cresciuto del 56%, toccando quota 185 miliardi alla fine dello scorso novembre. I 40 miliardari italiani più ricchi posseggono l’equivalente della ricchezza netta del 30% degli italiani più poveri (18 milioni di persone adulte). In un anno i depositi sui conti correnti sono aumentati di 110 miliardi. Spesso Giuseppe De Rita ci ha messo in guardia contro gli stereotipi sulla povertà, ricordando che c’è in Italia un risparmio privato tra i più elevati al mondo, che viene usato per creare altro risparmio. C’è un vasto patrimonio, che viene messo a reddito. Ci sono 16 milioni di pensioni che assolvono a funzioni sociali più rilevanti rispetto a quella di pura tutela per la vecchiaia e che riducono il rischio povertà per le famiglie più vulnerabili. C’è un welfare tra i più generosi d’Europa. E c’è infine un’economia sommersa che vale 190 miliardi l’anno, il 10,7% del Pil. Allora siamo ricchi o siamo poveri? Poiché, aumentano sia il benessere sia la povertà, la pista da seguire non è se siamo ricchi o poveri, ma quanto «disuguali». Le disuguaglianze sono il vero tratto distintivo di questo paese sempre più ricco, sempre più povero e sempre più indebitato. Una disuguaglianza riguarda il rapporto che i cittadini hanno con il fisco, dunque con lo Stato, dunque con gli altri cittadini. Sono in nero il 22,8% di ciò che accade nei settori del commercio, dei trasporti, della ristorazione e delle costruzioni, il 13,8% delle attività professionali, scientifiche, tecniche e ben il 36,4% delle cosiddette «altre attività» dei servizi. Non pagano contributi e tasse il 23% del lavoro domestico e il 17,1% di quello agricolo. Ovviamente nero significa imposte evase e, per le imprese, concorrenza sleale. Evasione esorbitante, soprattutto nel raffronto con gli altri paesi. Dati che smontano il pregiudizio per cui l’Italia sarebbe un paese strozzato dalle tasse. Elaborazioni effettuate su dati del ministero dell’Economia e dell’Agenzia delle entrate indicano che su 60 milioni e 400.000 residenti, quelli che hanno versato almeno 1 euro di Irpef sono stati 30 milioni e 600.000. Questo vuol dire che oltre il 49% degli italiani ufficialmente non ha reddito, e quindi non paga nulla di Irpef. Chi paga, allora, la maggior parte delle imposte? Quel 12,28% di contribuenti – ossia poco più di 5 milioni di soggetti – che dichiara redditi da 35.000 euro in su. Viene da loro il 58% delle tasse. È questo sparuto 12,28% della popolazione che tiene in piedi lo stato sociale, sono loro gli unici «oppressi» a cui potendo andrebbe ridotto il carico fiscale. Solo alcuni dati significativi, certo non esaustivi per rispondere alla domanda se siamo ricchi o poveri.
Un altro dilemma italiano è quello demografico. Siamo al terzultimo posto per tasso di fertilità e l’Istat ci dice che nel 2020 abbiamo avuto il minimo storico di nascite dall’Unità a oggi, 404.000, e abbiamo perso 384.000 residenti, come se fosse sparita una città grande quanto Firenze. I dati del 2021, complici pandemia e lockdown, confermano quello che viene definito «eccezionalismo demografico». I suoi ingredienti sono la struttura invecchiata per età, la bassa fecondità, la lunga transizione dei giovani allo stato adulto, i forti legami familiari, l’aumentata durata della vita, la veloce crescita della popolazione straniera, Aumentano gli anziani, diminuiscono i giovani e l’impatto economico si annuncia pesante considerato che meno siamo e più il debito pubblico peserà su ogni singola testa. Il confronto internazionale è impietoso. In due anni, tra l’inizio 2019 e l’inizio 2021, l’Italia ha perduto oltre mezzo milione di residenti; il Regno Unito ne ha guadagnati 600.000, la Spagna 400.000, la Francia 300.000, la Germania poco più di 100.000. Nell’arco dell’ultimo decennio, la popolazione italiana è rimasta praticamente stazionaria (–0,1%), in Francia è aumentata del 6,9%, nel Regno Unito del 6,8%, in Germania del 3,7%, in Spagna dell’1,6%. Ma da sette anni gli italiani sono in costante diminuzione. Antonio Golini, demografo, si chiede come siamo arrivati a considerare normale che le scuole si svuotino (100.000 alunni in meno da un anno all’altro) o che una regione come la Sardegna sia avviata a perdere entro pochi decenni un terzo dei suoi abitanti. Spiega come tutto ciò impatti sull’economia, sul welfare, sulla politica, sulla qualità della vita e propone vie d’uscita che hanno a che fare con lavoro, fisco, politiche migratorie, cultura. Quarant’anni fa in Italia vivevano 15 milioni di bambini e adolescenti. Adesso sono 10 milioni. I pensionati, che erano un quarto della popolazione, adesso sono un terzo. Una forbice che tende ad allargarsi e minaccia un’insidiosa crisi economica e irrimediabile, quando i pochi non basteranno più a garantire le pensioni e le cure dei molti. Di un’Italia sempre più longeva e spopolata l’unica parte che continua a crescere è quella che vive all’estero. Secondo i dati della Fondazione Migrantes e del suo annuale Rapporto sugli italiani nel mondo, dal 2006 a oggi il numero degli italiani residenti all’estero e iscritti all’apposita anagrafe è aumentato dell’82% e ha raggiunto i 5,6 milioni. Si tratta del 9,5% dei 59,2 milioni di italiani residenti in Italia. Stando ai dati dell’Ufficio centrale di statistica del ministero dell’Interno aggiornati all’inizio del 2020, le famiglie residenti all’estero sono 3.223.486. Una crescita ininterrotta della mobilità in uscita che fa ormai sembrare un fenomeno minore quella in entrata, cioè l’immigrazione. Non se ne vanno solo i laureati, che pure l’anno scorso sono stati il 30% dei nuovi emigrati, ma soprattutto i diplomati alla ricerca di lavori generici. Si emigra verso il Regno Unito (33.293), la Germania (13.990) e la Francia (10.562) che, da sole, coprono il 52,8% degli espatri. Se a queste aggiungiamo la Svizzera (8.189), che precede il Brasile (7.077), l’incidenza «europea» sul totale nelle prime posizioni arriva al 60,3%. Ma ci sono anche 10.000 italiani che hanno scelto di trasferirsi negli Emirati Arabi. Dei 130.000 che – nonostante la pandemia – se ne sono andati nel 2020, il 40% ha meno di 34 anni. Se a lasciare l’Italia inesorabilmente sono i giovani nel pieno della loro vitalità personale e creatività professionale, è su questi che si deve concentrare l’attenzione e l’azione. Urgono analisi e politiche finalizzate a un cambiamento di rotta nell’interesse dell’Italia tutta, dei suoi sempre più numerosi anziani che restano e dei suoi territori sempre più abbandonati e deserti. L’Italia che resta in Italia lentamente si modifica. Sono ormai un milione e mezzo gli stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana. Erano meno di 300.000 al censimento del 2001. Si chiamano nuovi italiani ma in realtà tanto nuovi non sono, visto che sono qui da almeno dieci anni. I più numerosi sono di origine albanese e marocchina, seguiti da rumeni, indiani, peruviani, tunisini, francesi, macedoni ma anche da discendenti di emigrati in Brasile e Argentina. Ci sono pochi cinesi perché Pechino non consente il doppio passaporto.
Tanti altri dati preziosi sono ricavabili dal volume. La politica, le istituzioni saranno permeabili alle sollecitazioni della realtà e della storia. Ha ragione Pagliaro quando afferma «che nulla, nel male e nel bene, ha cambiato il corso della storia di un paese sostanzialmente immobile, o se si preferisce, fedele a sé stesso». Difficile sapere come andrà a finire, quale sarà la sorte del nostro paese. E, purtroppo, ci sfiora il dubbio che, come ci insegnavano a scuola, il futuro dipenda da noi. «Destino e volontà son così avversi / che i nostri piani spesso vanno persi / nostri i pensieri, gli esiti mai» (Amleto, atto III, scena II), recitò uno dei maggiori scrittori di tutti i tempi.