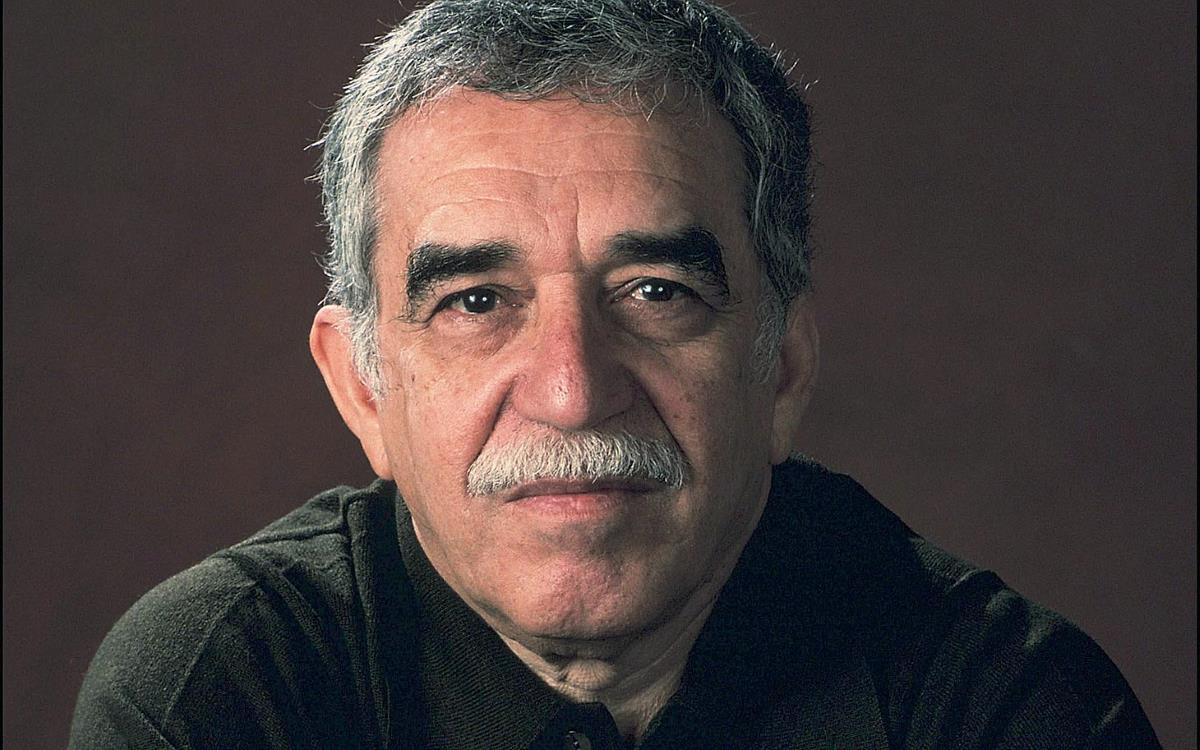di Rock Reynolds
Sostituzione etnica, sovranismo, politically correct, cancel culture, espressioni ormai entrate di prepotenza nel linguaggio quotidiano, solitamente sbandierate da chi non ama utilizzare i termini di cui vengono spacciate per sinonimi: razzismo, fascismo, verità scomoda, restituzione del maltolto fisico e culturale della storia. A farne abbondante uso è soprattutto chi vorrebbe tornare indietro nel tempo, regredendo a una sorta di ideale Shangri-La, di eden mai realmente esistito, in cui ogni gruppo etnico è al suo posto (leggasi nel continente di doverosa appartenenza) e ogni popolo virtuoso fa da sé (leggasi autarchia). Politically correct e cancel culture: alla faccia di chi vorrebbe imporre l’uso stretto dell’italiano nel nostro paese.
Il tema della sostituzione etnica, di cui non si sentiva minimamente la mancanza e il cui brusco ritorno di fiamma è merito – si fa per dire – del ministro dell’agricoltura, è un clamoroso autogol per chi ha la responsabilità di governare un settore produttivo un tempo fiore all’occhiello del nostro paese e oggi, comunque, ancora strategico. In nome di un presunto fai-da-te, si vorrebbe seriamente far raccogliere i prodotti della terra italiana agli italiani veri? Eppure, una buona fetta di tali prodotti resterebbe sugli alberi o sul terreno se a occuparsene non ci fosse un esercito di braccianti sottopagati, sfruttati, violentati. L’autarchia rimane, dunque, una parola vuota, le cui sinistre sfumature stanno acquistando contorni sempre più definiti e foschi. La plateale elusione delle norme di base che regolano le relazioni decorose tra datori di lavoro e fornitori di mano d’opera e la cancellazione conseguente dei diritti basilari dei braccianti sono un problema di tutti, non solo delle schiere dei diseredati, migranti stagionali, che raggiungono l’Italia dall’Africa, dall’Oriente e persino dall’Europa dell’Est: un problema grave. Un problema di tutti, ripeto, perché lo sfruttamento non guarda in faccia nessuno e perché consentire che, sotto gli occhi di tutti, si compiano soprusi e malefatte come quelli che avvengono quotidianamente nei nostri terreni agricoli rende deboli non solo i poveracci stranieri disposti a tutto, ma pure lavoratori italiani più fragili.
La Spoon River dei braccianti (Meltemi, pagg 171, euro 15) di Antonello Mangano, autore di numerose inchieste su questo tema, traccia un lucido, commovente, inquietante e persino avvincente quadro della situazione, narrandoci storie individuali di braccianti agricoli finite malissimo. L’Antologia di Spoon River, uscita tra il 1914 e il 1915, è una raccolta di poesie con cui l’americano Edgar Lee Masters dà voce ai defunti della comunità rurale immaginaria di Spoon River, tutti ospiti del locale cimitero, desiderosi di raccontare le loro storie che si intrecciano fino a creare un intrigante affresco d’insieme. È una simbologia forte, quella utilizzata da Mangano per tastare il polso al pubblico italiano, in un moment politico in cui i freni del pudore nel dire certe cose sembrano in via d’estinzione.
«Ecco un libro che bisognerebbe far leggere a scuola.» Ogni tanto mi è capitato di sentirlo dire e qualche volta ho pure condiviso il giudizio. La Spoon River dei braccianti di Antonello Mangano è davvero un libro che vorrei veder e sentir leggere non a scuola – o meglio, non solo a scuola – ma nelle piazze. Ha tutto per avere tale onore e responsabilità: è scritto mirabilmente e si può leggere come una vera raccolta di racconti, malgrado il tema unificante della sconfitta dell’umanità da cui filtrano davvero pochi lumicini di speranza, e affronta la questione della sospensione palese dei diritti dei lavoratori fornendo la giusta dose di informazioni.
Come detto, le storie sono drammatiche, di una tristezza sconfortante. Ma questa è la situazione e indorare la pillola non sarebbe stato un buon servizio per nessuno. Ci sono braccianti sottopagati (praticamente tutti), in larga parte vittime di un caporalato che non li equipara nemmeno a dei numeri, considerato che molti non esistono per lo stato italiano e, dunque, rientrano solo in statistiche presunte sul lavoro sommerso. Ci sono donne e uomini il cui cuore non regge alla fatica e alle condizioni climatiche tremende. Ci sono esponenti di etnie che diventano vittime di altre etnie sfruttate, com’è d’uso in tutte le terre coloniali, dal padrone per far rigare dritto la massa. Vi sono giovani che si adattano alla meno peggio e accampamenti da rione dantesco nei quali l’umanità assume un suo ritmo quasi normale, malgrado la negazione delle più umili norme igieniche e di sicurezza che nella società italiana dovrebbero vigere ovunque.
Leggete questo libro: vi donerà ricchezza, umanità, conoscenza. E leggete le parole che Antonello Mangano ci ha voluto dire, con altrettanta lucidità.
Ci spieghi per sommi capi come è arrivato a concepire questo libro.
Il libro nasce dalla necessità di parlare di lavoro, migrazione e sfruttamento in termini concreti, evitando categorie generiche o astratte. Per farlo, mi è sembrato utile usare una tecnica narrativa, che permette di andare dal particolare al generale. Spero che il lettore, in questo modo, possa empatizzare con situazioni che spesso vediamo come lontane, ma anche capire che certi fenomeni sono strutturali e dipendono solo in parte dalla volontà dei singoli.
Le storie di queste povere persone le ha ricostruite tramite i classici canali di ricerca o in qualche caso ne ha conosciuto personalmente i protagonisti?
Ho visto praticamente tutti i luoghi e ho conosciuto molta gente. In nessun caso, la vittima. Spesso, però, gente che la conosceva. Ho voluto inserire in un apposito capitolo tutte le fonti, per chiarire l’origine delle informazioni. Spesso si parla genericamente di “schiavi”, senza approfondire i dettagli e l’aspetto umano. È il cosiddetto “paradigma miserabilista”, quello di chi dice “poverini” e pensa che ciò basti a rappresentare un’umanità molto complessa e articolata.
È quasi inevitabile parlare dell’attuale situazione politica italiana e internazionale. Cosa pensa si possa concretamente fare? Da una parte ci sono i proclami del blocco navale e via dicendo, dall’altra la realtà di un fenomeno, quello migratorio, che nessun tipo di misura restrittiva può realmente contenere. Si può governare un movimento di massa del genere?
Premetto due cose. Nel libro si parla anche di una lavoratrice italiana, Paola Clemente. Questo per dire che lo sfruttamento non è “etnicizzabile”. Colpisce le persone più ricattabili, ma non per questo riguarda solo i migranti. In secondo luogo, non saprei affrontare la questione in termini così generali. Ma di una cosa sono sicuro. Non è corretto parlare di “deboli”, ma di “indeboliti”. Non di poveri ma di “impoveriti” e così via. Anche i “clandestini” sono resi tali, attraverso la negazione dei documenti. Sembra che ci sia un’idea coerente nella legislazione: rendere ricattabile il lavoratore migrante attraverso la negazione dei diritti. Riformare la legge sull’immigrazione mi sembra il primo passo. Assegnare documenti a tutti, senza scadenza. Creare vie d’accesso legali. Poi si può anche discutere in generale, ma intanto eliminiamo le storture più evidenti.
“Aiutiamoli a casa loro!” Finché non ci sarà un cambio di paradigma umano nelle società ricche, mi pare una frase paternalistica e ipocrita. Lei che ne pensa?
Penso di sì. Nel libro spiego che la migrazione da alcuni paesi africani ha una sua semplice logica economica: partire da luoghi dove i salari sono bassi e andare a rivendere la propria forza lavoro a un miglior prezzo in Europa. In questo modo, con le rimesse, si mantiene la famiglia allargata. È un modello, non è il frutto della “disperazione” di cui si parla a sproposito. Il paternalismo e l’atteggiamento coloniale sono connaturati al dibattito pubblico sulla migrazione. Anche questo è un problema strutturale.
Come si può convincere il nostro popolo che “prima gli italiani” non solo è moralmente discutibile ma pure una mistificazione? Insomma, siamo sicuri che un paese che non si prende carico della debolissima categoria degli immigrati abbia poi lo spirito per occuparsi di tutte le altre categorie deboli interne?
Ma siamo sicuri che esista la categoria degli immigrati? In questo calderone mettiamo gente appena arrivata che vuole ricongiungersi ai familiari, persone in transito, seconde generazioni, lavoratori e lavoratrici presenti da molto tempo. Sono esseri umani che hanno aspirazioni, obiettivi, idee ed esigenze molto diversi tra loro. Non è detto che occorra “prendersi carico” di tutti. In molti casi basterebbe riconoscere diritti: allo spostamento, alla cittadinanza. “Prima gli italiani” rappresenta anche questo: una legislazione speciale che nega diritti anche a chi li ha acquisiti col lavoro e il sacrificio.
Cos’è che realmente impedisce al paese di votare una legge sullo Ius Soli? E cosa si può fare per fare una comunicazione chiara al popolo, di modo che capisca che non si tratta di una limitazione dei diritti degli italiani?
In materia di immigrazione, si gioca molto su paure ed emotività. La contrapposizione all’altro è l’unica fragile ideologia che ha permesso alla Lega di essere il più longevo gestore del potere dal 1990 ad oggi. Il nemico è spesso mutato: dal meridionale al migrante. Ma il modello è rimasto identico. La negazione dello Ius Soli fa parte di questo sistema. Non si nega l’acquisizione della cittadinanza, ma la si rende complicata, vessatoria.
Nelle sue ricerche, si è mai sentito sotto minaccia?
No. In realtà mai.