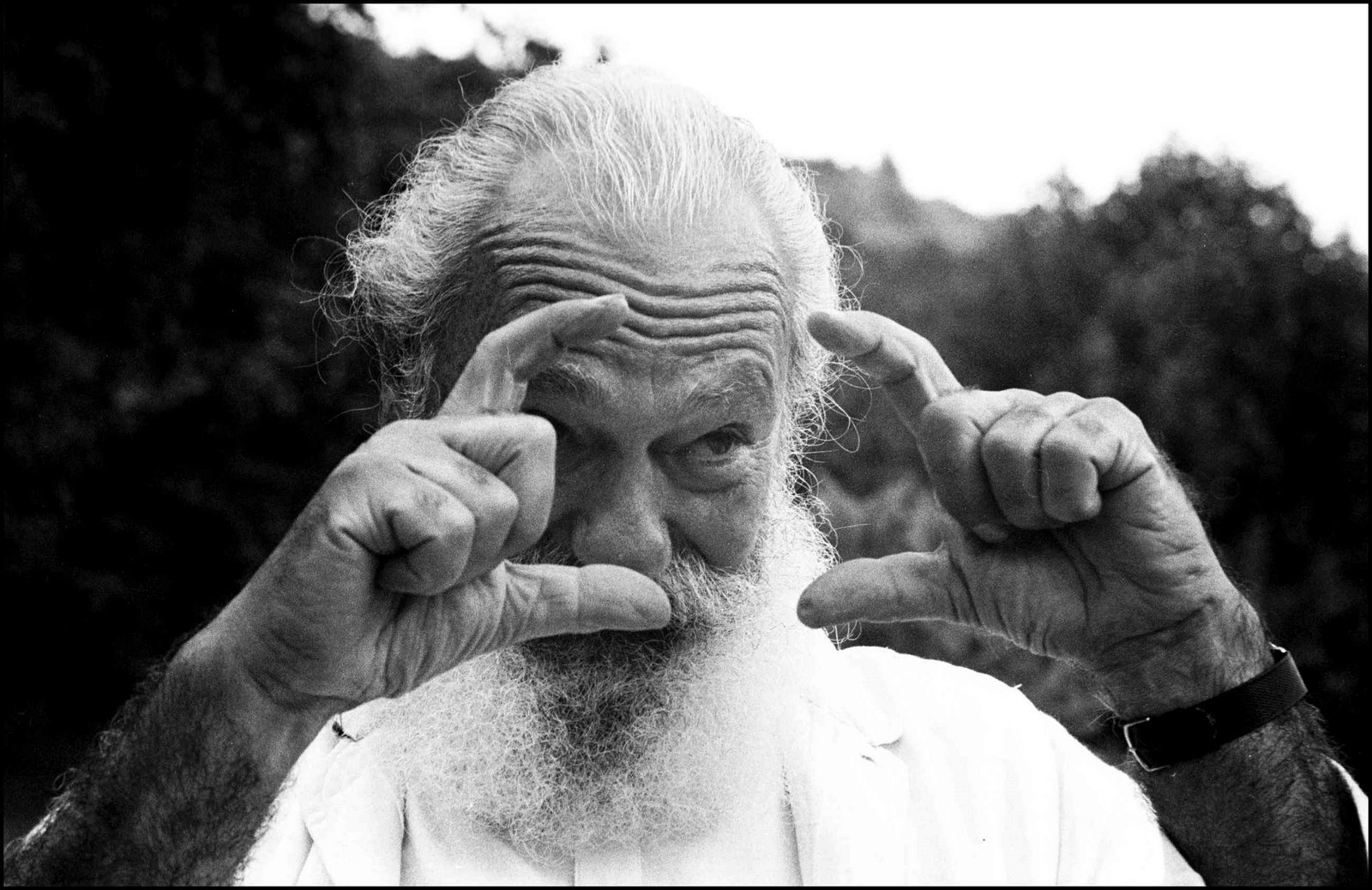di Antonio Salvati
I briganti sono noti per essere stati certamente protagonisti di sanguinosi scontri con le truppe del nuovo Stato unitario nei primi anni sessanta del XIX secolo. Nell’immaginario collettivo hanno rappresentato diverse cose: simbolo del ribellismo e dell’identità meridionale (o della sua arretratezza), ma anche banditi, criminali comuni, partigiani, giustizieri, vendicatori sanguinari. E soprattutto accusati di essere al soldo di coloro che sognavano il ripristino del vecchio regno di Francesco II. In realtà – come i recenti studi storiografici hanno rilevato – fecero parte di un fenomeno decisamente più articolato.
Valentino Romano ha arricchito i suoi studi sul brigantaggio con un godibile volume Filomena, la regina delle selve Storia e storie delle donne del brigantaggio (Carocci 2024, pp. 216, € 22), in cui ancora una volta cerca di dar giusto rilievo al ribellismo contadino, «ora disprezzato, ora minimizzato», troppo spesso trattato con prevenuta sufficienza dalla storiografia risorgimentista, «forse anche perché potenzialmente suscettibile di incrinare i miti monolitici del processo unificatore della Nazione e della connessa retorica patriottarda sui suoi padri fondanti».
Lo fa raccontando la storia della “brigantessa” Filomena Pennacchio, una donna che impugnò le armi, che trascorse gli anni giovanili nei boschi della sua terra, anni popolati da atrocità, uccisioni, ruberie, tradimenti, pericoli, odi, incertezze, insicurezze. Una donna che dimostrò a sé stessa e alle altre donne che era possibile un’altra scelta. Leggendo le pagine dei tanti processi per brigantaggio celebrati nei tribunali ordinari nel decennio 1860-70 si evince la consistente partecipazione, pur in una assai variegata diversità di ruoli e di forme, delle donne alla ribellione sociale e antiunitaria delle classi subalterne. Si stima che furono oltre centocinquanta le donne in armi, più del doppio alla macchia e almeno cinquemila, a vario titolo, fiancheggiatrici della rivolta. Furono protagoniste di una lotta (rozza e non raffinata dall’ideologia) contro l’oppressione della famiglia patriarcale, contro le angherie della società maschilista locale «e, solo in ultima battuta, contro le leggi imposte da uno Stato “estraneo”: un’opposizione individuale, istintiva e confusa a regole imposte a vario livello, sulla scia e in conseguenza di quella maschile, che comunque costituì un primo ma deciso passo in direzione dell’assottigliamento delle differenze di genere». Lo fecero anche sapendo di correre il rischio di tagliarsi i ponti con altri affetti. Erano consapevoli che la loro scelta avrebbe innalzato un muro tra loro e il consorzio civile, ma scelsero lo stesso una strada fatta di solitudine. In molti casi sarebbero state disconosciute e allontanate persino dalle proprie famiglie; «sapevano anche che al loro “buon nome” era indissolubilmente legato quello della loro famiglia, che venendo a mancare quello sarebbe venuto meno anche questo e che la famiglia, infine, per difenderlo, sarebbe stata costretta a ripudiarle pubblicamente. Ma, nonostante tutto e nonostante tutti, lo fecero ugualmente».
le storie di Filomena e di tutte le altre donne dei briganti continuano a oscillare ancora tra realtà e fantasia, negli immaginari ora mitizzanti o demonizzanti. Come spiega Romano, furono donne con tutte le coerenze e contraddizioni, le fragilità e la determinazione, il coraggio e le debolezze, gli slanci e gli abbandoni, le generosità e le crudeltà del loro essere. La vicenda umana di Filomena e delle sue compagne è, «a un tempo, sussurro e grido, singhiozzo soffocato e risata sguaiata, lamento e sorriso, tenerezza e crudeltà, rabbia e serenità, vendetta e perdono, irriducibilità e pentimento; è, insomma, tutto ciò che contraddistingue l’essere umano nelle sue molteplici sfaccettature». Per questo, solo per questo, oggi, dovremmo ricordare queste donne, «testimonianza di genere di un’umanità dolente che contribuì – oggi non importa più se dalla parte giusta o da quella sbagliata – alla costruzione della Nuova Italia e che la battezzò anche del suo sangue; e, se pure tardivamente, dovremmo restituire a ciascuna di esse quella normalità che la vita non volle o non seppe riconoscerle». Abbiamo approfondito questi argomenti con Valentino Romano.
Perché un altro saggio sul brigantaggio e, in particolare, sulle donne che vi parteciparono?
Per molti motivi, ma per due in particolare: il primo scaturisce dalla considerazione che, spesso, nella storiografia sui processi formativi della Nuova Italia (sia essi quelli maggiori, sia quelli cosiddetti minori) le donne che se ne fecero parte e, talvolta, anche da protagoniste, subirono e subiscono ancora un processo di espulsione, di rimozione. O comunque di marginalizzazione di “genere”. Sicché delle donne che, seppure in ruoli o con funzioni diverse, vi parteciparono, oggi si conosce ancora poco o nulla, essendo tale conoscenza limitata al più alle cronache criminali o alle narrazioni (spesso voyeuristiche) di scrittori d’evasione.
Il secondo motivo si collega direttamente al primo: queste donne, oltre i loro meriti e le loro colpe, scontano la pena immeritata della mistificazione, soggiacendo allo scontro ideologico – alimentato da un incredibile proliferare di pubblicazioni non sempre puntuali e quasi mai obiettive – in atto negli ultimi decenni tra “unitaristi” duri e puri e “nostalgici del bel tempo che fu”; di conseguenza, queste donne – in virtù delle contrapposte letture ideologiche – vengono rappresentate via via o come criminali e donne di malaffare o come eroine partigiane del Borbone.
Tentare di sottrarle all’oblio e allontanarle quanto più possibile dalle mistificazioni, restituendole a ciò che – a mio parere – hanno, nel bene e nel male, realmente rappresentato, mi è sembrato un atto doveroso di ripristino di varie verità, di restituzione alla memoria collettiva e, allo stesso tempo, l’input per una più pacata e approfondita discussione sull’argomento, svincolandolo da ogni schematismo ideologico preconcetto.
Considerate le dimensioni della presenza femminile nel brigantaggio meridionale si può parlare di “fenomeno di genere”.
Credo proprio di sì. A confermarlo sono i numeri, per come – pur solo parzialmente – emergono dai processi cui queste donne andarono incontro e dei quali vi è ancora traccia negli archivi: più di centocinquanta quelle che parteciparono in armi alla vita della macchia; oltre cinquemila quelle accusate di manutengolismo, cioè di favoreggiamento – a vario titolo – dei loro uomini latitanti.
Tutte ribelli scese in campo per difendere il Borbone?
No, anche se è comprovata nell’agire di alcune di esse la motivazione “legittimista”, spesso mediata da quella dei loro uomini.
E allora perché scesero in campo?
Non si comprende a fondo il ribellismo conosciuto come “brigantaggio” se non lo si contestualizza nel tempo, nel mondo e nella cultura delle classi subalterne agrarie meridionali all’indomani del processo di unificazione; ancor più non si comprende l’agire ribelle di queste donne se non si tiene conto della condizione esistenziale nelle quali versavano, condizionate com’erano da un maschilismo esasperato e da una sudditanza di genere tale da far sostenere, per esempio, al Pani Rossi come la donna di metà ottocento nell’economia della società rurale meridionale e nella famiglia espressione di questa società, venisse dopo “il porco domestico”. La verità è che queste donne, avendo covato e accumulato un odio di genere all’interno di questa società oppressiva, in un momento di rivolgimento e confusione istituzionale, lo agirono all’esterno e si dettero alla macchia inseguendo un sogno confuso ma prepotente di affrancamento individuale, anche rivendicando il diritto di autodeterminazione degli affetti.
Femministe ante litteram, dunque?
No, assolutamente. Il femminismo, a mio avviso, è la presa di coscienza di una condizione complessiva di genere, presuppone un comune progetto “politico” a medio o a lungo termine, si pone, insomma, in ultima istanza l’affermazione dei diritti generali di “genere”. Nelle donne del brigantaggio questo non c’è: ognuna di esse reagisce a una singola condizione esistenziale, si oppone ad essa, vuole combatterla, si propone di superarla; ed è lotta individuale e non collettiva i cui obiettivi sono, innanzi tutto, la sopravvivenza immediata all’insegna del carpe diem. L’aspetto “rivoluzionario” del loro agire sta nella determinazione e nel coraggio che queste donne mostrano in un momento cruciale della loro esistenza, quando scelgono di saltare il fosso che divide la “normalità del consorzio civile” e “l’anomalia della macchia”; portano, insomma, il cuore nel bosco. Qui sta tutta l’eccezionalità, non altrove.
Mi pare di capire che non condividi l’etichetta di “eroine” …
Infatti! Così come non condivido quella di “criminali”. Innanzi tutto, sono contrario alle generalizzazioni, sempre e comunque. In particolare, mai come in questo caso bisogna scavare nei singoli vissuti, nell’agire di ciascuna di queste donne. A me pare che esse siano donne normali che hanno avuto il torto di vivere in un periodo che “normale” non è stato. E hanno reagito come meglio hanno saputo o potuto fare. Non tocca a me emettere giudizi moralistici. Semmai, cerco di comprendere i motivi della loro scelta.
Una scelta che è figlia della speranza di una vita più umana?
Dipende! In alcuni casi lo è sicuramente, in altri è la spia della perdita di ogni speranza (come nel caso di una di esse che sosteneva “dove corre corre la mia pianeta”, cioè non m’importa di quel che sarà). Comunque una scelta non a cuor leggero, ben sapendo ciò a cui si andava incontro: si pensi, ad esempio, alle difficoltà della vita alla macchia di una donna, spesso unica, in un gruppo maschilista. E non aggiungo altro.
Perché ha scelto Filomena Pennacchio come fil rouge della storia di queste donne?
Perché Filomena, per me, rappresenta il paradigma di tutte le donne del brigantaggio: nella sua vicenda umana convivono amore e odio, violenza e tenerezza, irriducibilità e cedimenti, sconforto e speranza. Tutti sentimenti contrastanti ma ugualmente presenti nell’animo umano. Ecco, mi sembrava il soggetto adatto a rappresentare tutte e ciascuna delle storie delle donne che rappresentarono l’altra metà del purgatorio delle classi subalterne meridionali. In questi ultimi anni si è scoperto il luogo preciso dove Filomena è stata sepolta; a Torino, dove scontò parte della pena inflittale, dove rimase una volta libera, dove sposò un agiato borghese. Recentemente, quasi in contemporanea con l’uscita del mio libro, l’abbiamo ricordata là e abbiamo posto una targa commemorativa. Nel segno della rimozione di ogni rancore e divisioni passate e nello sforzo di eliminazione di quelli tuttora persistenti anche (ma non solo) nella storiografia di settore, in un’ottica di sola laica comprensione degli avvenimenti, lontana dal tifo da stadio che ancora la contraddistingue.