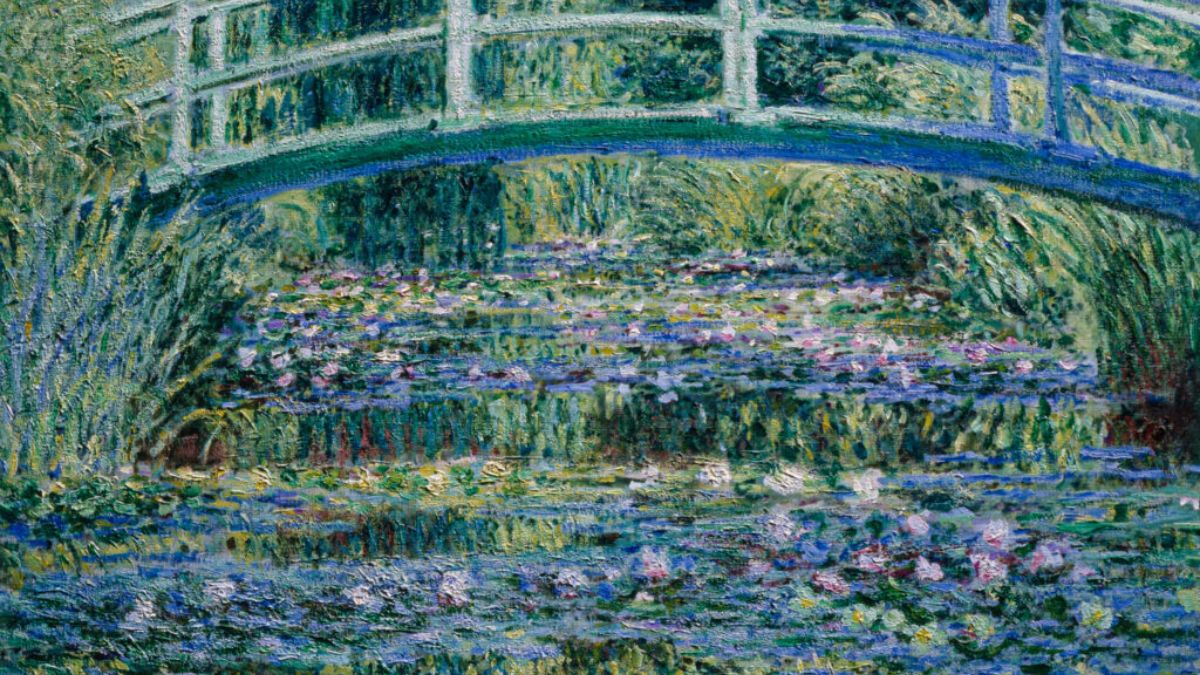di Alessia de Antoniis
Una generazione di arrabbiati, frustrati, odiatori seriali sui social, omofobi, razzisti. Che ricordano gli anni Ottanta come una sorta di Atlantide dove tutti vivevano felici. Sono i nati tra gli anni Sessanta e Settanta. Come Eleonora Danco.
Lei che al GinesioFest ha riproposto, tra l’entusiasmo di una platea piena di giovani, i suoi cavalli di battaglia, “Me vojo sarvà” e “Nessuno ci guarda”, lava in pubblico l’infanzia e l’adolescenza di un’intera generazione: la sua. La nostra. Magari per questo, tra il pubblico presente, chi ha meno apprezzato il suo teatro sono stati coloro i quali hanno sentito, forse, risuonare vecchie corde messe a tacere dagli anni e dalle convenzioni sociali.
In fondo, quella masnada di disadattati sociali che urla e sussurra in scena la Danco, viene dalle borgate romane, parla un romanaccio volgare, rozzo e irripetibile. Parla di adolescenza, conflitti familiari, sesso, dipendenze. Parla di periferie. Ma se ripulisci il linguaggio, entrambi i monologhi sono un pugno nello stomaco di tanti. Anche dei quartieri bene. Raccontano una realtà trasversale fatta di genitori anaffettivi, regole senza senso (posso bagnarmi i piedi in mare? No!), di proibizioni aggressive (Devi stare zitta, non devi parlare), umiliazioni gratuite (come sei sciupata, sei brutta, ma che ti sei fatta spuntare i capelli? ti hanno rovinato, ma ti lavi i capelli? sembra che hai i pidocchi, ti lavi? ti lavi? Questa non si lava, questa all’età sua non si lava. Non mi davi neanche il tempo di darti un bacio, mamma). I personaggi di Eleonora Danco parlano a tanti di noi.
Un corpo esile che sembra perdersi nei pantaloni cargo e la camicia oversize lasciata aperta, un po’ da maschiaccio. Una voce che cambia tono e volume in maniera frenetica, una gestualità polifonica che passa da un istante all’altro da un personaggio all’altro. Con l’energia di una ragazzina al debutto, nonostante la Danco riempia i teatri da oltre quindici anni con questi testi, i due atti unici sono ancora energetici e coinvolgenti. Due flussi di coscienza, un caleidoscopio di personaggi e situazioni borderline. Una danza della disperazione. Come in trance, la performer romana fluisce da un personaggio all’altro, da un monologo all’altro. Riempie uno spazio vuoto, privo di scenografia, il cui unico difetto, almeno nella versione ginesina, è l’eccessiva mancanza di luce che la rende, a tratti, poco visibile anche dalla prima fila.
“Me vojo sarvà”, recitato col romanaccio delle borgate, della gente di strada. Un monologo serrato, maniacale, senza respiro, schizofrenico, compulsivo. Esci non esci… Rispondo non rispondo… Dormo non dormo…non me ricordo più gnente…che c’è da ricordà, da pijà, da pensà…certi giorni te sveji fresco come l’ova e certi giorni te viene dentro da ammazzà quello che vicino se beve er cappuccino…so n’anima in pena non trovo pace…
Il testo della Danco oscilla tra umorismo caustico, linguaggio crudo, disperazione quotidiana (So distrutta so arivata so sconvolta so sfinita c’ho mar de testa de piedi sto sempre ar telefono devo pagà er gas c’ho mancanza de sonno de fero de potassio so anemica so pallida magnate le banane bevite la spremuta so anemica c’ho l’asma c’ho due de pressione), nevrosi. Una tela variopinta di rabbia e tenerezza, frustrazione e poesia. Un grido di disperata speranza: Vorrei prende le sembianze de n’uccello, un giorno solo, du minuti, aprì l’alette annammene lontano, me vojo sarvà…me vojo sarvà).
La potenza di queste drammaturgie è frutto del meticoloso modo di lavorare dell’artista, che non si abbandona all’autocommiserazione e non ha come fine quello di generare pietà nello spettatore. La vedi lì, buttata a terra, per strada, sporca, e resti impassibile come davanti a un invisibile sdraiato su uno dei tanti marciapiedi di una metropoli. Un teatro, il suo, estemporaneo solo in apparenza, mentre ha l’unico fine di arrivare alla pancia dello spettatore, senza astrazioni mentali o giochi psicologici.
Entri nelle ferite aperte di una ragazzina che si innamora di suo padre (Papà devo dirti tante cose papà papà…), che si sente rifiutata da sua madre (Lo so che sei gelosa di me e io l’ho capito quando da grande papà si è innamorato di me senza saperlo e tu stavi sempre a trovare difetti – Ti odio vorrei che tu morissi non so che significa morire è solo doloroso farlo con questo coltello a seghetta che hai comprato da Upim. Non posso farcela), che scappa per paura.
Ma in tanta rabbia, la Danco trova la forza di sussurrare parole folli con infinita tenerezza: Mamma vedo le stelle, mamma mi sto per uccidere perché mi hai cambiato i jeans che mi ero comprata da sola per la prima volta in vita mia e non mi hai detto niente.
Le periferie della Danco non sono quindi quelle sociali, ma quelle umane, che hanno lo stesso odore nelle borgate e nei quartieri alti. Quelle periferie umane dove affondano le radici di una generazione frastagliata, seghettata come il coltello della Upim, discontinua, interrotta. Che ricorda gli anni Ottanta come un’araba fenice. Che non riesce a chiudere, e spesso nega, le sue ferite e urla, con la volgarità dei sentimenti che i personaggi della Danco hanno nel linguaggio, la sofferenza dell’anima. E un buio che non è solo quello di scena.
Che confusione mamma, che confusione fuori e dentro di me, che mi sbatte da una parte all’altra ma tanto io ho tutta questa memoria negli occhi, che mi salva la vita con tutte lacrime mie, le più belle lacrime mie. Vedrai mamma, andrà tutto bene. Come sempre vero? Come sempre no? Sono le 11 fatevi il bagno.