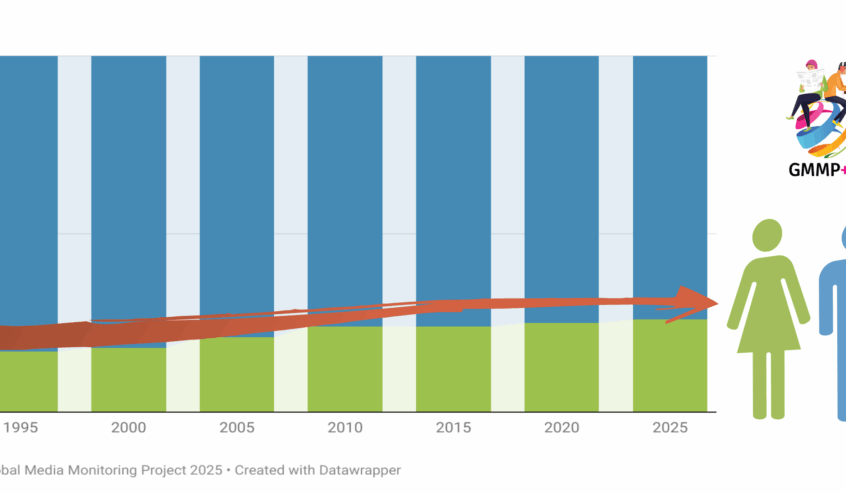Su Repubblica Enrico Franceschini afferma che “nel 1991 con l’Urss noi giornalisti eravamo più liberi di oggi”. Ricorda “le mani che tremavano” del neonominato capo della giunta politico-militare che aveva organizzato il golpe di agosto, “il nervosismo e l’incertezza” del capo del Kgb e del ministro della Difesa, quasi a presagire il fallimento del golpe. Le “stazioni radio indipendenti che trasmettevano la cronaca del colpo di stato in diretta”.
E osserva “l’impressionante differenza tra la libertà in cui operavano allora i media nazionali e internazionali in Russia e il misto di censura, oppressione e segretezza in cui sono costretti ad operare oggi, sotto il tallone di ferro di Putin e dei suoi epigoni”.
Il documentario su Berlusconi e un servizio sul caviale mentre è in atto la marcia su Mosca di Primozhin, l’azione dei censori per impedire perfino le ricerche su Google, i self-video di Putin e dell’uomo delle caverne della Wagner, l’informazione sostituita dalla propaganda di regime. Conclude che “fare il giornalista oggi a Mosca è infinitamente più complicato e rischioso che al tempo del golpe del ’91”.
Tutto vero. Ma non è solo in Russia e nelle dittature che funziona così. Dal 1991 è cambiato il mondo. Se da un lato l’avvento di Internet e del digitale hanno reso più difficile la censura, dall’altro il potere, a tutte le latitudini, ha affinato tantissimo le azioni e le tecniche per condizionare, orientare, limitare o impedire la libera informazione.
Gli sconvolgimenti nel mondo dell’editoria hanno fatto il resto. I corrispondenti dall’estero e gli inviati di guerra ormai sono una merce rara, solo le gradi testate se li possono permettere. Sempre più spesso ascoltiamo servizi che ci raccontano cosa succede in un determinato paese redatti però dalla capitale di un altro paese distante migliaia di chilometri.
Vediamo “reportage” costruiti con lanci di agenzie governative, immagini e video realizzati da altri. Per non parlare dei pezzi fatti sulla base dei tweet e dei video-comunicati dei politici di turno, che ormai sono la norma.
Tutti i regimi e tutti i poteri, dittatoriali o democratici che siano, sono diventati abilissimi a mettere sotto tutela i media e a manipolare l’informazione. All’”imbavagliamento” non sfuggono nemmeno gli inviati di guerra. E lo stiamo vedendo anche in Ucraina.
Dall’invasione dell’Iraq in poi la gran parte dei giornalisti inviati al fronte lavora a sovranità limitata, si muove al seguito o nelle zone controllate dall’esercito “democratico” che gli permette di arrivare in certi campi di battaglia, di parlare con certe persone, di realizzare certe immagini e non altre. Si dirà, sì, ma almeno lì possono andare, mentre nei territori occupati dai regimi dittatoriali no. Resta il fatto che la verità è sempre più la prima vittima delle guerre. E che, come cantava De Andrè, “bisogna farne di strada per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni”.