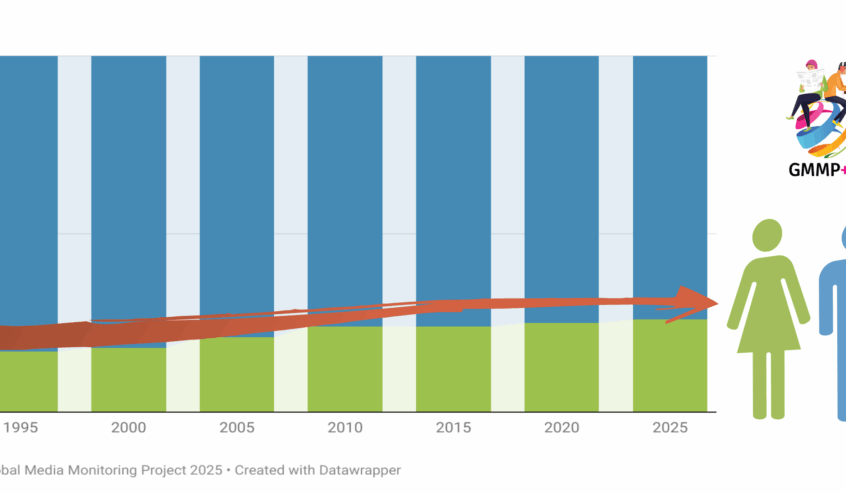La destra al governo non ama il pluralismo delle idee. Stiamo assistendo, infatti, ad una poco commendevole occupazione dei luoghi (veri o presunti che siano) del potere: anche – eccome – culturale.
Per ciò che concerne l’editoria si è sostituito immantinente, ad esempio, il presidente del Centro per il libro e la lettura Marino Sinibaldi, a riprova della tendenza.
Non c’è traccia di una riforma reale, a meno che non si voglia contrabbandare per tale un brutto articolo della legge di bilancio di quest’anno sulla definizione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione (previsto dalla legge n.198 del 2016) che diventa «unico», vale a dire comprensivo di ricchi e poveri.
Eppure, sta accadendo di tutto: il parlamentare di Fratelli d’Italia Antonio Angelucci (con vasti interessi nelle cliniche private e alla faccia del conflitto di interessi) intenderebbe aggiungere alla sua collezione proprietaria diretta o indiretta –Il Tempo, il Giornale, Libero, il gruppo capeggiato dal Corriere dell’Umbria– l’Agenzia Italia voluta dall’Eni di Enrico Mattei, il cui nome è evocato spesso senza costrutto. E voci si rincorrono sulla Repubblica, con buona pace di Carlo Caracciolo e di Eugenio Scalfari.
Inoltre, incombe l’intelligenza artificiale, che sovverte forme produttive e paradigmi dell’informazione storica.
Un terzo delle edicole italiane ha chiuso e altre sono prossime alla crisi, mentre gli studi specialistici suppongono che dopo il 2030 la carta stampata sarà solo un ricordo.
Ecco perché si rendono indispensabili dei correttivi immediati al testo in esame alla Camera dei deputati del cosiddetto «milleproroghe», per evitare che le testate cooperative o di opinione vengano taglieggiate a partire dal 2025 in ossequio ad un comma mai abrogato della legge n.145 del 2018. Insomma, la bufera è in atto e ci si accanisce soprattutto contro coloro che non hanno e non potrebbero neppure avere un peso di mercato. Parliamo de il manifesto o dell’Avvenire, ma pure delle numerosissime testate del mondo associativo ed ecclesiale.
Siamo di fronte, come nel caso del ricorso alle querele bavaglio, ad una censura mascherata.
Pure sotto il profilo dell’evocato spirito di mercato i conti non tornano. Si pensa da parte dei sacerdoti del liberismo che un’azienda sia in grado di sopravvivere senza avere certezze sulle entrate e l’opportunità di programmare il proprio lavoro?
C’è da augurarsi che gli emendamenti dei gruppi del Partito democratico e dell’Alleanza Verdi-Sinistra italiana -insieme a quelli di diverso segno pure annunciati- siano la scintilla utile ad accendere il dibattito.
L’Italia è sotto osservazione in Europa con Ungheria e Polonia per la preoccupante situazione del e nel sistema mediatico. Le minacce e gli attacchi a chi cerca di raccontare con coraggio e indipendenza la verità si sprecano. E il precariato dilaga, costituendo ormai buona parte dell’attività giornalistica.
Che non finisca come in passato in una pratica burocratica da evadere. Sarebbe ora che il sottosegretario con delega Alberto Barachini uscisse dal suo eccessivo riserbo e dicesse qualche parola: dal 2025 dobbiamo assistere alla morte in diretta di svariate testate e ad un ulteriore incentivo alla disoccupazione?
La decrescita infelice non giova a nessuno. La riduzione del peso di un segmento già assai indebolito dell’industria culturale è un colpo all’edificio democratico, fondato sulla Costituzione e sull’articolo 21 in essa contenuto.
Si accolgano gli emendamenti e si istruisca un gruppo che studi davvero percorsi e ricette per non uscire dal villaggio globale.