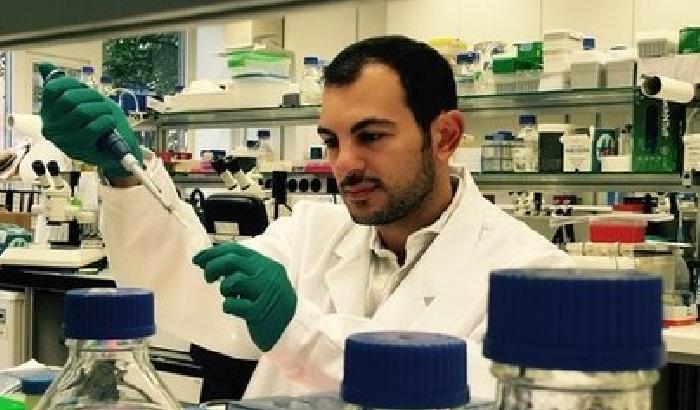Era di lunedì il 30 agosto 1965, a Mattmark Cantone Vallese della Svizzera sotto la parete est del Monte Rosa. Da poco le 17,15 di un giorno come un altro, perché nel cantiere della Electro Watt per la costruzione della diga a 2150 metri nella lingua del ghiacciaio dell’Allalin – la Strega – si lavorava anche di domenica, cosi anche il giorno di Pasqua. Undici ore di lavoro come da contratto, che spesso diventavano anche sedici. Tanto freddo, nevicava in piena estate, ma lì c’era solo da lavorare con le mani livide per il gelo.
Francesco Achenza di Uri, provincia di Sassari, ha 38 anni quando scrive al fratello Sebastiano: “non è bello lavorare di notte, siamo dentro una tomba, non vediamo nulla, siamo circondati da montagne e non vediamo altro che neve. Non voglio che dite niente ai miei, dite che è un bel posto” – Nicola Verna “Bruciati dal ghiaccio”.
L’inferno all’improvviso: il vento che schiaccia l’aria senza fare rumore come il lancio delle bombe, quando si stacca il capello di ghiaccio della Strega che precipita nell’imbuto in fondo alla valle. Sono due milioni di metri cubi di candidi macigni, un’onda bianca alta quaranta metri che travolge ciò che trova frantumando le baracche della mensa, quella dei sondaggi, l’officina con gli uffici, uomini che volano come farfalle con le ali spezzate, bulldozer giganteschi schiacciati come moscerini. Poi il boato, troppo tardi, quando tutto è già finito. Ma non è così: 88 vittime, 56 erano italiani, anche una donna, 17 del Bellunese, 8 calabresi, 4 abruzzesi, 5 trentini, 3 campani, 3 emiliani, 3 friulani, 3 pugliesi, 3 siciliani, 2 piemontesi, 1 molisano e 1 toscano. Altri due sardi: Olivio Dessì, trentacinquenne di Senorbì ed Antonio Floris di Orgosolo. Le pietose e difficili operazioni di recupero dei corpi si conclusero solo a dicembre. Furono impiegati i lanciafiamme e le mine per sciogliere quelle rocce di ghiaccio, l’ultimo corpo sarà ritrovato due anni dopo nell’agosto del 1967.
Mattmark a distanza di anni è una sorta di Marcinelle dimenticata, perché i migranti non sono mai stati uguali, neppure dopo la morte. Sono gli anni della costruzione dei grandi bacini idroelettrici. Come le rondini giungono a primavera, un esercito di lavoratori stagionali, 570 mila sono gli italiani che varcano il confine Elvetico. Una corsa contro il tempo ad imbrigliare le risorse energetiche in alta montagna. Del resto la Svizzera è l’unico paese d’Europa ad avere conservato indenne il proprio tessuto industriale, è solo un problema di manodopera.
Fatale l’incondizionata fiducia verso nuove tecniche edilizie troppo ardite, che non vuole sentire quel sinistro scricchiolio del ghiaccio quando si stacca, che avvertono in alta quota solo quei lavoratori a metà strada tra scalatori, minatori e terrazzieri. Irresponsabile la mancata sorveglianza fotogrammetrica del sito che oltre a lamentarsi si muove continuamente. I lavori si dovevano concludere prima del prossimo inverno, di spostare più a valle il cantiere in condizioni di maggiore sicurezza, neppure a pensarci. Fu una scelta determinata dal risparmio di tempo e denaro. La catastrofe non fece eccezioni anagrafiche, neppure a 24 vittime di nazionalità svizzera tra tecnici e maestranze. Non bastò più il silenzio dei ghiacciai perenni a nascondere quelle proibitive condizioni di lavoro.
Più di duecento corrispondenti accorsi a commentare in diretta quel disastro. Testimonianze, inchieste giornalistiche e giudiziarie non attestarono però alcuna colpa contro i 17 imputati. L’ultimo atto presso i tribunali a settembre del 1972 ha il sapore di un’autentica beffa, i familiari delle vittime saranno condannati a rifondere le spese processuali con tremila franchi.
Le macerie delle guerre lasciano sempre desolazione mentre poche ombre si allungano ingombranti sugli anni a venire. Dietro la faccia spensierata del boom economico si nascondono i sacrifici di una vita. In quei giorni Presidente del Consiglio è Aldo Moro agli Esteri Amintore Fanfani, il Governo non presenzierà ai funerali. Dall’antica Terra di Lavoro, dal fascino tormentato dell’Irpinia alle coste del Salento, dalla Sila e dall’Abruzzo lungo il travagliato cammino della speranza il Mezzogiorno aveva già iniziato il suo spopolamento. La sola Svizzera assorbirà il 50% di quell’esodo epocale.
In Europa gli accordi si sono sempre raggiunti anche nell’intervallo tra le due guerre mondiali. Il 23 giugno 1946 Italia e Belgio ne firmano uno per l’impiego dei minatori italiani, confermando una precedente intesa del 1922. Non più quella del grano ma la cosiddetta battaglia del carbone, il disastro bellico aveva archiviato ogni velleità di politica estera. I fattori di scambio furono 2500 tonnellate di carbone ogni mille operai. Fu allora che comparvero gli accattivanti manifesti di colore rosa a cura della Federazione Carbonifera Belga: viaggio gratuito di sole 18 ore, contratto di lavoro annuale, carbone gratis, assenze giustificate per motivi di famiglia, ferie contrattuali, la possibilità di essere raggiunti dal proprio nucleo familiare.
Dalla stazione di Milano a Bruxelles il viaggio durava due interminabili giorni, un convoglio di mille passeggeri chiusi dentro i vagoni dall’esterno, per non avere la tentazione di scendere in territorio svizzero. Superata Basilea erano riaperti, tanto in Francia non sarebbe sceso nessuno. Arrivati a destinazione l’alternativa era cantines oppure hangar, fra baracche e vecchi ricoveri di campi di concentramento, tra il caldo ed il freddo non c’era molta differenza ma tanta sofferenza.
I cartelli “ni animaux, ni étranger” sbarravano le porte al mercato delle locazioni, come anni più tardi a Torino faranno “non si affitta a meridionali”. La malattia era quasi assicurata, con la garanzia di cinque anni di lavoro in miniera pena l’espulsione dal Belgio.
Grazie all’apporto dei lavoratori emigrati il Belgio e la Svizzera raddoppiarono il prodotto nazionale lordo, mentre nel secondo caso si moltiplicano le paure ataviche dell’inforestiamento italiano. Ripetuti tentativi xenofobi per fortuna non ebbero la meglio. L’associazionismo sindacale a prezzo di non poche discriminazioni, insieme alla ripresa economica nazionale riuscirono a garantire maggiori tutele, ridimensionando con l’avvento della ripresa economica i flussi migratori. Molti integrandosi in quelle comunità decisero di restare, altri come oltre mille vittime sul lavoro nella Confederazione Elvetica non ebbero altra scelta. Prevalse il buon senso e la vocazione pacifica di quei territori, perché come fu scritto nel raffronto tra il dare e l’avere lo sbilancio era tale al punto di aver già dato la propria vita.
Sul Corriere della Sera del 1° settembre 1965 fu la prestigiosa firma di Dino Buzzati a raccontare quella tragedia sul lavoro. L’incipit si apre con Achenza Francesco con il capo cantiere alla fine che spunta sul registro degli assenti il nome di Floris Antonio. “Chi sapeva che foste a lavorare così in alto tra quelle montagne riprodotte scintillanti da quelle cartoline plastificate a colori, che si mandano a casa” Quasi due anni da Longarone (Belluno) il disastro del Vajont con 1917 vittime, bellunesi sono le 17 vittime dell’Allalin. Per il giornalista non è più questione di mestiere o di fantasia “stavolta è una faccenda personale perché quella è la mia terra, quella è la mia gente”.
Ieri le valigie di fibra tenute strette anche dai tanti nodi in gola, oggi il Mediterraneo che si chiude sopra mille naufragi, un camion frigo fermo con dentro senza più aria carne da macello, che là dove oggi sorge un’autostrada fu bersaglio dei cannoni in un’Europa senza più pace. È già troppo tardi quando i paragoni possono diventare inganni della Storia.
“Emigrazione, vecchia amara nostra favola che non finisce mai” scriveva Dino Buzzati, incredulità non solo delle parole.