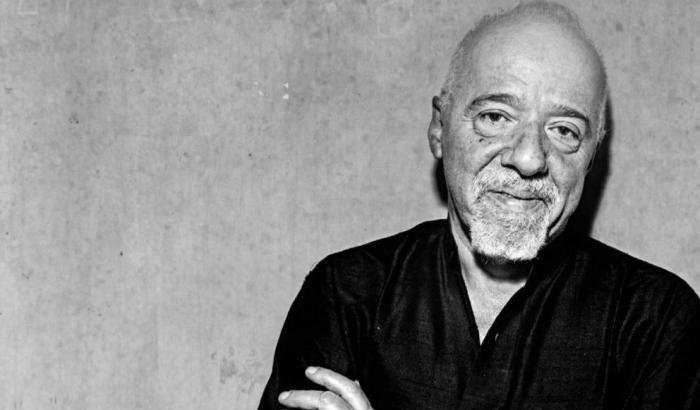di Emilio Scibona
Scrivere un “coccodrillo” non è mai semplice in generale. Non lo è a maggior ragione in quest’era nella quale financo la morte, in dispregio al confacente e necessario rispetto che in tutti i casi essa implica nei confronti del defunto e del dolore dei suoi familiari, non è risparmiata dalla ricerca dei numeri e del consenso sulla quale si basano le modalità della comunicazione 2.0
Lo sport, al pari delle varie forme di rappresentazione, è un generatore di coinvolgimento emotivo e l’atleta più di tutti è il catalizzatore di emozioni che, nel bene o nel male, lascia sempre un segno destinato a diventare parte dei propri ricordi. Poco importa se si tratta quasi sempre di persone delle quali conosciamo solamente una facciata mediatica che può essere pacificamente distante dalla realtà: quello tra appassionato e sportivo è un legame basato innanzitutto sul pathos. Ed è proprio per questo che la morte di un atleta, a prescindere dal suo livello, colpisce spesso dritta al cuore.
La scomparsa di Kobe Bryant non può dunque che assomigliare in tal senso ad un fendente brutale. Aveva smesso di giocare a pallacanestro dopo vent’anni di carriera tre anni e mezzo fa: tanto tempo sì ma non abbastanza per considerare la sua figura come appartenente al passato, inteso non in senso letterale come tempo che ci precede ma in senso emotivo, ovvero come tempo nel quale non ci si riconosce più. L’8-24 dei Los Angeles Lakers anche fuori dal parquet restava un’icona del basket contemporaneo.
Un pezzo della vita sportiva di un enorme numero di appassionati che più che andarsene viene letteralmente strappato via da una sorte infausta, improvvisa e brutale come quella che sorprese Gaetano Scirea trent’anni fa. Dispiace profondamente l’idea in sè, fa male leggere i dettagli di quella che è stata una tragedia con altre 8 vite spezzate su quel maledetto elicottero, tra cui quella della secondogenita di Bryant, Gianna Maria Onore, giovane cestista che sperava di seguire la strada del padre.
Bryant è stato uno dei più grandi cestisti di tutti i tempi. A dirlo sono i trionfi, i numeri e soprattutto quello che c’è stato dietro questi, ovvero un’etica del lavoro ferrea alimentata da una personalità molto competitiva e soprattutto dalla devozione nei confronti dello sport del quale è stato a lungo l’emblema principale. Sarebbe stato bello vedere se in futuro si sarebbe seduto sulla panchina di una franchigia da allenatore, magari proprio ai suoi Lakers. Purtroppo non lo sapremo mai: quel che sappiamo è che abbiamo avuto la fortuna di vedere giocare uno dei più grandi professionisti di sempre.